Pindaro ha chiesto con smacco sottolineato alla Musa di ispirarlo, così che lui potesse agire come profeta: colui che parla per conto di terze parti. Alle spalle delle Muse si trovava Apollo. E Apollo da chi aveva appreso l’arte di conoscere il passato, il presente e il futuro. Tra le ipotesi sul campo, possibile che sia stato Pan a dargli delle dritte. Non a caso Apollo avrebbe accordato la sua lira (ricavata da una testuggine, dopo del fratello Ermes) usando proprio il flauto di Pan. Più verosimile forse che la mantica sia un regalo ctonio, che venga dunque da Gea.
Sembrerebbe, in questa seconda ipotesi, che per conoscere la volontà dei celesti (di Zeus, più propriamente) sia imperativo avere trafficato con quanto accade sotto la superficie della terra. Gli oracoli, primo tra tutti quello a Delfi, erano posti in prossimità di fonti; qualcosa doveva affiorare dal sottosuolo, prima di essere bagnato dalla luce, dalla volontà di Zeus. E, se diamo retta a Eraclito, se è vero che tutto governa il fulmine (ed è vero che tutto governa il fulmine), abbiamo solo da far scegliere al nostro avversario l’arma con la quale imprimere il colpo esiziale. Che il fulmine sia un traslato per la volontà, ancora, di Zeus? O che sia una freccia di Apollo? Spesso più cieca e cattiva nel portare a compimento la volontà dei celesti? (Chi moriva giovane e di morte improvvisa si diceva che Apollo lo avesse colpito con un suo dardo; e la colpa era di Artemide se a morire era una giovane.)
Platone, più smaliziato e forse ottuso, prendeva quasi in giro Ione per l’invidia che gli dimostrava (per bocca di Socrate, nel dialogo). Ione se ne tornava da Epidauro, aveva vinto una gara poetica in onore di Asclepio (figlio di Apollo…), e nel giro di pochi scambi di battute quasi ammette che la conoscenza di rapsodo non è farina del suo sacco. Piuttosto è il dio a visitarlo, lo ispira come può accadere con una menade, e il compito che gli spetta è esclusivamente di riferire quanto detto. L’epistème, la conoscenza razionale, è tutto un altro affare che non lo riguarda. L’epistème è una cosa da filosofi.
Grazie al cielo le posizioni al riguardo (poesia è pura ispirazione e alterità? È tecnica, artigianato?) sono sfumate nel corso dei secoli a venire. Il manicheismo, nella teoria della letteratura, o meglio in un genere specifico: la lirica, è un atteggiamento infantile e antico insieme.
Aristotele aveva intuito il valore gnoseologico della poesia. Della tragedia in realtà: e la catarsi (una proiezione degli umori degli spettatori sul palco del teatro) si qualificava per lui come un processo fisiologico. Quasi un drenaggio di quella emotività che a Platone già dava le nausee (entrambi i filosofi si erano scordati, se non per brevissimi incisi, di come alle spalle del teatro ci fosse un altro dio, Dioniso, e di come il suo ruolo nei Misteri fosse introdotto da un poeta: Orfeo. Entrambi, di nuovo, scordavano di come la poesia fosse ancillare rispetto al passo ultimo dei Misteri, l’epoptèia, la visione delle cose ultime).
In mancanza di questa esperienza, a chi rivolgersi per attingere alla verità? Quali fondamenta dare ai dispositivi di conoscenza, e di sempre nuova integrazione dell’io con la sempre nuova percezione della realtà?
Francesco Giusti sta su questo solco. Le pagine dedicate a questa ricerca si intitolano Il desiderio della lirica – Poesia, creazione, conoscenza (Carocci Editore, 24,00 Euro). E bisogna sottolineare quali passi Giusti ha lasciato dietro di sé, prima di arrivare qui. Non più tardi di due anni fa, Giusti esordiva come critico grazie ai tipi di Textus Edizioni, con la ricerca Canzonieri in morte – Per un’etica poetica del lutto. Sempre lirica, sempre l’io che si esprime, ma in sottrazione, nel vuoto di una perdita. Il mondo implode perché Orfeo si è voltato; Euridice è morta per sempre. (Euridice muore sempre perché ci sia canto? L’assenza è unica condizione del canto?)
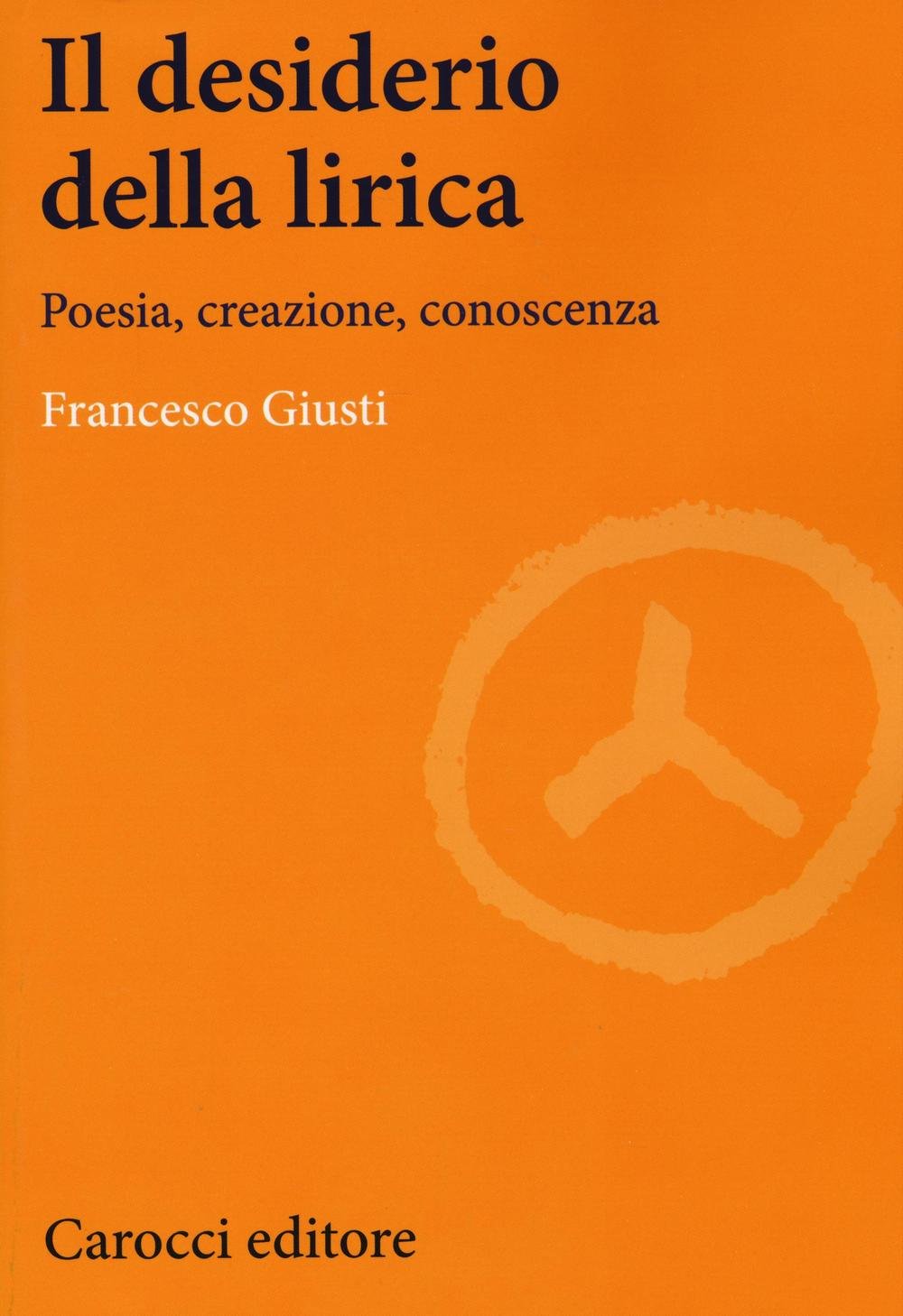
Dall’abbandono, setacciato con i versi di Montale, Dunn, De Angelis, Hughes, al vuoto che accoglie la divinità, l’ispirazione. Non a caso in una delle mitologie orfiche, prima che Eros faccia la sua comparsa è necessario che appaia il pieno di un uovo, fecondato dal vento, generato dalla Notte, che si culla nel vuoto dell’Erebo, del buio. Forse senza averne coscienza, e felicemente sarebbe da aggiungere, Giusti sta nel mezzo di queste due alterità: il pieno del dio che visita, il vuoto dell’assenza.
Il catalogo su cui ragiona Giusti è vasto e ponderato. E se con Stesicoro, tra il settimo e il sesto secolo a. C., al poeta viene riconosciuto un ruolo attivo, specie nella scelta degli argomenti, con Pindaro, di nuovo, viene stabilito una volta per tutte il doppio nodo tra sophìa e techne: l’una è espressa dall’altra, l’altra non ha ragione d’essere se non in funzione della prima; per Bacchilide si tratta di lavorare con la tradizione, in combinatoria. L’arte non è più il cosa, è il come. (Pindaro credeva ancora alle Muse, a suo modo; Bacchilide è già laicamente smaliziato). E Dante, colpevole di una invocazione alle Muse appena ritardata nel primo canto dell’Inferno, aveva comunque riconosciuto ad Amore un ruolo di ispirazione, seguito dalla sua volontà di dire, di cantare.
L’ispirazione cessa di essere una furia cieca, viene allora mantecata dalla interpretazione, dalla meditazione paziente di quanto ascoltato. Appunto Dante, a Bonagiunta Orbicciani: «E io a lui: “I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo ch’e’ ditta dentro vo significando”.» Quanto siamo lontani da uno dei primi stati depressivi messi in rima: «Solo et pensoso i più deserti campi /vo mesurando a passi tardi et lenti». Nel Purgatorio Dante trova la forza di spiegare cosa accada: Amore è il diapason, lui risuona in quel diapason, su quella nota costruisce. Petrarca fa del suo vuoto ispirazione.
Il processo di interiorizzazione che sembra radicarsi in Dante e Petrarca ha la sua origine in Aristotele. La poesia non è per lui una imitazione di terza categoria, è in realtà l’imitazione di una immagine mentale innescata dal poeta, e da chi ascolta. La poesia ha il dono dell’universale, la storia indugia nei meandri del particolare. La verosimiglianza, se non la realtà, sono un limite. La catarsi poetica è una distillazione, primo momento che porterà a un margine di più diffusa intelligibilità.
Ma da Aristotele a noi? Sue sembrano essere le fondazioni di una creazione, e fruizione, più psicologizzate del verso. Giusti sottolinea la non-mediazione della poesia moderna (ha in mente, e passa in rassegna, Valéry, almeno, e Wordsworth, Rilke): non più una donna, non certo le Muse o la presenza del dio, quanto la natura (o la Natura, per essere più vicini a Hoelderlin), il corpo. O, meglio ancora, la coscienza. Perseo dovrà durare molta fatica prima di guardare negli occhi la Medusa.




16 Comments