Cosa rimane della guerra in Iraq? Sì, intendo a parte una situazione in Medio oriente radicalmente peggiorata, un paese smembrato e diverse decine di migliaia di morti e feriti. Posto che si possa dire una guerra effettivamente conclusa e non solo il principio di un caos ormai ultradecennale in quell’area. Il 1º maggio 2003 Bush dichiarava missione compiuta. A giugno 2016 c’è stata un’offensiva per riprendere Fallujah e pochi mesi fa è cominciata quella per sottrarre Mosul dalle grinfie dell’Isis. Insomma, la fine delle operazioni militari non ha certo coinciso con la pace, la democrazia e il principio di un radioso futuro.
Senza riandare con la memoria alle due guerre mondiali, la guerra in Vietnam, perfino quella in Corea e la prima guerra del Golfo hanno fatto da sfondo a una serie di opere e hanno attorno a sé un immaginario che, forse, le ultime guerre al terrore –inaugurate sotto la gestione di Bush Jr – non hanno. Queste due guerre le conosciamo più che altro attraverso l’onnipresenza normalizzante e anestetizzante nei tg e l’estetica di videogiochi e di film come The Hurt Locker e American Sniper. Le immagini della statua di Saddam che cade e quelle delle torture inflitte dai militari ai prigionieri iracheni di Abu Ghraib. Le balle sbugiardate di Bush e Blair sulle armi di distruzione di massa, i faccioni di Dick Cheney, Condoleezza Rice e Donald Rumsfeld. E un paio di manciate di buoni libri.
1. Phil Klay Fine missione, traduzione di Monica Pareschi, Supercoralli, Einaudi 2015

Perché così pochi buoni libri?
Forse perché: «con internet puoi passare tutto il giorno a guardare la guerra, se vuoi. Video di sparatorie, attacchi di mortaio, ied, c’è di tutto. Ci sono marines che spiegano cos’è il caldo del deserto, cos’è il freddo del deserto, cosa si prova quando si spara a un uomo, cosa si prova quando si perde un marine, cosa si prova quando si uccide un civile, cosa si prova quando si viene colpiti».
La qualità dei racconti di Klay è altalenante, ma la scrittura vividissima, specie nelle descrizioni degli scontri a fuoco, rasenta punte di durezza e iperrealismo tali da farci sembrare nel mezzo dell’azione, come fossimo in uno sparatutto in prima persona. Nessuna delle molte (troppe?) voci riesce a raggiungere l’intensità di quella di Fine missione il racconto che dà il titolo alla raccolta e costituisce il vero e proprio pezzo forte dell’armamentario dell’ex marine Phil Klay, che con questo libro ha vinto il National Book Award nel 2014. Spesso, quasi sempre, si tratta di ex militari alle prese con il redeployment, ovvero il ritorno alla vita civile, e quindi l’onnipresente post traumatic stress disorder («un’invenzione del New York Times») è inesorabilmente il filo rosso che lega queste storie tra loro. Ma si può davvero mai ritornare a una vita normale? Per i militari è un fine missione mai, visto che anche quando sono dentro a uno strip club o aspirano da un narghilè nel tentativo di impressionare una ragazza che si è appena convertita all’islam gli è impossibile non fare i conti con le immagini e le voci della guerra che si affastellano nelle loro menti.
Ma non ci sono solo i commilitoni. A essere protagonisti di Fine missione sono anche figure spesso più in ombra, i fobbit, per esempio, gente che che raramente lascia la base (la fob appunto), proprio come gli hobbit, noti pantofolai poco amanti delle avventure. A loro ha dedicato un romanzo satirico David Abrams nel 2012, intitolato giustappunto Fobbit. Ma restando a Phil Klay, ci sono anche cappellani prevedibilmente alle prese con l’eterno problema della teodicea, scribacchini il cui compito è buttar giù in burocratese il miglior encomio possibile per far prendere a un povero cristo morto ammazzato la Medal of Honor, ingegneri alle prese con superiori che vogliono imporre il baseball come sport nazionale agli iracheni, marine becchini dell’unità mortuaria che si trovano all’improvviso ad avere a che fare con i corpi delle spogliarelliste e non più con i cadaveri, gente che è andata in Iraq a riparare le buche ed è tornata scarnificata.
A un senso dell’umorismo brutale e spesso proprio questo rinfrancante (come le parole d’esordio: «Sparavamo ai cani. Non per sbaglio. Lo facevamo di proposito, e la chiamavamo Operazione Scooby») fa da contraltare una sfilza di immagini atroci e atrocemente prevedibili. E del resto i soldati sono ragazzi di diciotto diciannove vent’anni, che d’improvviso si ritrovano catapultati in una situazione di prossimità assoluta con la morte. Lo humour, quasi sempre cinico e diffusamente macabro, serve ad allontanarne la realtà, la fisicità della minaccia, che rimane sempre presente come un basso pulsare che scandisce le giornate e i minuti. Sono ragazzi cresciuti con film d’azione e videogiochi in cui subito dopo aver premuto il grilletto la battuta è d’obbligo per alleggerire la tensione, inevitabile che siano esperti al riguardo.
I militari disprezzano chiunque non sia stato in quell’inferno (la battuta che ricorre è: «Quanti veterani del Vietnam servono per cambiare una lampadina? Che cazzo ne vuoi sapere, tu non c’eri») e sono ragionevolmente piuttosto insensibili alle nuances: per loro sono tutti hajji da ammazzare. Perché l’hanno fatto, perché si sono arruolati? Forse per i duecentocinquantamila dollari all’anno [sic!](( Questa la cifra citata nel testo: gli stipendi a cui si fa riferimento in altri libri menzionati in quest’articolo sono assai più contenuti. Un esempio in I più soli dei soldati di Helen Benedict: «io, che ero un E-5 con otto anni di servizio, guadagnavo la miseria di 33mila dollari l’anno, senza nemmeno l’indennità di rischio».)) o per sfuggire alla noia suburbana e buttarsi di testa in un mare di guai? Nessuno si interroga sui perché e figuriamoci poi se ha gli strumenti per rispondere concretamente. L’approccio più comune è quello esistenzialista e stolido: «si sono arruolati perché si sono arruolati», «siamo in guerra perché siamo in guerra».
Klay per fortuna non rende le cose facili al lettore, non occhieggia e anzi infittisce i suoi racconti di una serie di sigle e acronimi (paradigmatiche in questo senso le tre pagine di Oif, per veri e propri iniziati). Il gergo militare diventa centrale per districarsi nelle sue pagine e gli occhi del lettore devono scalfire questa corazza per carpire il cameratismo e l’isolamento impermeabile della vita soldatesca. Il microcosmo del plotone ha una lingua tutta sua e la cosa non è affatto casuale: c’è bisogno di una lingua che rifletta il cambiamento di scenario e la mutata condizione dell’essere umano ora in guerra, questo se si vuole rimanere in vita, altrimenti si comincia a pensare alla fidanzata a casa, agli hamburger di quel diner all’angolo tra Michigan Avenue e la Quattordicesima, alla tv al plasma e si finisce con una pallottola in fronte. E non potrebbe essere altrimenti: appena ci si arruola si viene ribattezzati, si entra in una nuova dimensione dell’agire umano, si cambia, si diventa qualcun altro lasciandosi per sempre alle spalle il sé precedente. Lo sforzo di Klay nel riprodurre su carta questo gergo militare e la mutata realtà delle cose all’interno dell’esercito è ammirevole e riuscito; si vede che Tim O’Brien ha fatto scuola in questo senso. Fatto sta che dopo la lettura di Fine missione sigle come Coin o Ied assumeranno tutt’altra luce per voi.
In Fine missione Bush è citato una sola volta: quanto Agamben e Fanon, ma anche quanto Call of Duty. Il primo racconto è una bomba a mano, ma gli altri, a eccezione di Corpi, vivacchiano sulla sua dirompente onda lunga, più di luce riflessa che di altro. Bello ma pretenzioso, pretenzioso ma bello.
2. Kevin Powers Yellow Birds, traduzione di Matteo Colombo, Stile Libero, Einaudi 2013.

Finalista al National Book Award nel 2012, e vincitore del PEN/Hemingway e del Guardian First Book Award in qualità di miglior esordio dell’anno, Yellow Birds è un libro che tra gli altri è piaciuto a Dave Eggers, Michiko Kakutani, Tom Wolfe, Alice Sebold e Philipp Meyer e che quest’anno finirà sul grande schermo (nel film ci sarà Jennifer Aniston qualora quest’informazione possa essere rilevante nel 2017).
Una cosa piuttosto inevitabile d’altronde: se per Klay il riferimento sembrano essere i videogiochi, nel libro di Powers si intuisce una presenza piuttosto ingombrante del grande immaginario cinematografico di guerra statunitense. Ci troviamo sottufficiali che perdono le staffe e stendono a pugni soldati semplici rei di aver fatto promesse impossibili da mantenere alla mamma di un altro cadetto e battute memorabili che starebbero bene in bocca al sergente Hartmann:
«“Morirà della gente” disse impassibile. “È un fatto statistico”».
E laddove il lirismo nel veterano Klay era sacrificato alla narrazione scarna e cruda, il veterano mitragliere Powers, da poeta qual è, ha un certo gusto per la descrizione e il figurato, e ci si ritrova spesso a perderci di fronte all’immagine vaporosa del laghetto nella terra natia o a quella dei frutteti martoriati di Tal Afar. Tutto il romanzo si muove tra flashback e flashforward tra la Virginia e l’Iraq e il dispositivo narrativo è pensato e ragionato come una specie di mystery già risolto nelle prime pagine. Sappiamo subito chi muore, sappiamo chi si sente responsabile di questa morte, non sappiamo perché.
A rubare la scena è un personaggio immancabile eppure come da pronostico spettacolare, ossia il sergente Sterling, la cui onomastica mi pare tutto fuorché casuale (potremmo tradurre sterling con ottimo, eccellente, perfetto, ma anche argentino e dunque scintillante) e che pure con la sua maschera inappuntabile e la sua mascella squadrata finirà per essere un agente affatto passivo nello sgretolamento di due vite.
Gli altri due protagonisti sono il ventunenne Bartle e il diciottenne Murph, che finirà ucciso in battaglia. Due ragazzotti della Virginia sballottati su un campo di battaglia mediorientale che instaureranno un’amicizia titubante, ammesso che si possa chiamarla tale. Murph cerca rassicurazioni e Bartle si erge a fratello maggiore, ma non sarà in grado di salvare né lui né se stesso. Li seguiamo nell’addestramento, nella calura infernale dell’Iraq e, perlomeno per uno dei due, alle prese con i rimorsi di un ritorno inglorioso nella terra dei reality, dei centri commerciali e della trombosi venosa profonda. Una volta tornato, come un automa, Bartle continuerà a cercare con le mani il suo fucile che ora non c’è più e rimarrà in quella condizione esistenziale che è l’Awol, absent without official leave, assente senza autorizzazione, disperso senza una motivazione plausibile.
Se l’esercito è un posto in cui scomparire, tenere la testa bassa e fare come ordinato, senza aspettative e senza attendersi ricompense, la guerra è una cosa assurda e inimmaginabile, per quanto prossima possa essere, e al contrario di quello che ci hanno sempre insegnato non unisce, ma divide. Ci rende tutti dei solipsisti che per aver salva la vita sperano muoia il compagno, non foss’altro che per una mera questione statistica. Contenti di averla sfangata per un’altra giornata, di non essere al posto di chi non ce l’ha fatta. Ogni morte altrui non è che un’affermazione della propria vita. Guardando i ritratti di quelli che ci hanno lasciato le penne, i soldati sono tentati di scorgere ogni tipo di possibile stramberia o eccentricità, così da poter dire: se la sono cercata. La salvezza è nell’ordinarietà, ancora una volta, nello sparire dai radar e tenere giù la testa, ma non c’è salvezza, non c’è libertà nell’essere privi di responsabilità.
Un ottimo esordio, un libro da leggere, che smitizza la guerra per quello che è – riprendendo una sua immagine assai potente: come le cattedrali è ammantata di bellezza per nascondere l’orrore che vi si cela dentro –, ma che, come nel caso di Klay, non è il capolavoro che questa guerra attendeva.
3. Saïd Sayrafiezadeh, Brevi incontri con il nemico, traduzione di Gioia Guerzoni, Codice edizioni 2016

Paradossalmente è proprio un libro con un approccio meno realistico (e a dirla tutta anche un po’ una forzatura in questa lista visto che la guerra in Iraq non viene mai chiamata per nome anche se è onnipresente nelle pieghe dei racconti) a riuscire meglio dei due precedenti a tratteggiare quel clima straniante di placida isteria e distanza ravvicinatissima da una guerra percepita come onnipervasiva eppure lontana migliaia di chilometri. Come vedono il conflitto gli assistant manager di Walmart che rubacchiano dal proprio supermercato per conquistare il cuore di ragazze ebree con la parrucca? Come la prendono quando gli dicono che il loro collega abbastanza scemo da arruolarsi è morto in combattimento?
Saïd Sayrafiezadeh, una volta che riuscirete a padroneggiare lo spelling, dalla sua prospettiva di americano atipico e proprio per questo tipico (figlio di un iraniano e di una ebrea, entrambi socialisti) cerca di dare una risposta al perché nell’epoca del torpore piccolo–borghese si diventa coscritti: impressionare le ragazze, alzare due soldi, fare curriculum, ricevere attenzione. Sono tutte «motivazioni sbagliate» chiaro, non possono essercene di giuste.
Relazioni e amicizie che nascono e soprattutto si sfaldano nella più quieta indifferenza, tutto avviene in un paesaggio suburbano punteggiato di bandierine a stelle e strisce e in un ambiente antropico surreale in cui i rapporti sono come azzerati e tutti sembrano aggrappati agli usi e ai costumi di un’era precedente a un anno zero che è impossibile da identificare. In questo contesto algido e funzionale, i reduci vengono accolti come fossero eroi. Anche quando hanno passato il tempo a girarsi i pollici o a sparare a nemici più che altro immaginari: magari un padre e un figlio che arrancano su una collina lunare, mentre noi li osserviamo sfocati dal mirino dell’annoiato cecchino in cerca solo di qualcosa da raccontare una volta a casa, di un’emozione che sia una. D’altronde, la guerra è combattuta sempre altrove, ed è una faccenda puramente tecnologica in cui i fanti sono ancor meno che pedine e i fucili hanno grilletti ipersensibili che rispondono alla minima pressione, capaci come sono di uccidere il nemico a chilometri di distanza.
Chi è il «nemico» per questi «Tim o Tom», anonimi abitatori di monolocali squallidi e altrettanto asettici, o magari cuochi svogliati o facchini in cerca di promozione? È un nemico impalpabile eppure immanente. Lo conoscono di riverbero tramite il chiacchiericcio di giornali e tivù. Si sta ritirando e i nostri sono a ottanta, anzi quaranta chilometri dalla capitale, gli stanno alle calcagna, è questione di giorni. Ma ecco che le cose si mettono male, cominciamo a perdere uomini, «la Penisola» (l’Iraq non è mai nominato e difficilmente lo si potrebbe definire una penisola) diventa a un tratto meno rassicurante. E come interagiscono la Nazione e la Guerra? Tutto il libro sembra un tentativo di chiarirlo: la seconda sembra organica e necessaria alla prima. Grazie alla guerra le fabbriche lavorano a pieno ritmo, i supermercati sono pieni, il nemico è altrove, «noi» siamo okay, tutto in ordine.
Scevro dalle elucubrazioni poetico-filosofiche di Powers e dall’iperrealismo esasperante e pirotecnico di Klay, Brevi incontri con il nemico cattura e racconta gli Stati Uniti di quegli (questi?) anni, la loro afasia, la rinuncia a capire e a indagarsi in quanto società, sebbene abbia la pecca, alla lunga, di risultare un filo troppo ripetitivo in questa sua circolare ossessività.
4. Ben Fountain, È il tuo giorno, Billy Lynn!, traduzione di Martina Testa, minimum fax 2013
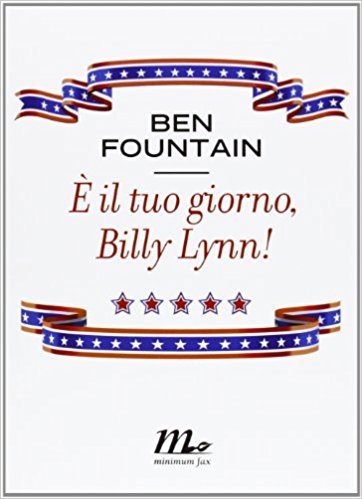
Hanno perso Shroom e Lake, solo due uomini, potrebbe dire un addetto alle cifre, ma dato che ciascun membro della Bravo è scampato alla morte per una questione di centimetri, la percentuale dei caduti avrebbe benissimo potuto essere del cento per cento. È la maledetta casualità che ti logora, il fatto che la differenza fra la vita, la morte e una ferita tremenda a volte è legata a cose minime come chinarsi ad allacciarsi una scarpa, scegliere il terzo cesso della fila invece del quarto, voltare la testa a sinistra anziché a destra. Casualità. Quanto ti incasina il cervello, questa roba. Billy ne ha percepito il potenziale di devastazione mentale la prima volta che sono andati in missione fuori dalla base, quando Shroom gli ha consigliato di stare seduto con un piede davanti all’altro invece che coi piedi paralleli, così se un ordigno improvvisato lanciato dal bordo della strada contro l’Hummer lo avesse perforato da parte a parte Billy magari avrebbe perso un piede solo anziché due. Dopo due settimane passate tenendo i piedi perfettamente in linea, le mani ben infilate dentro il giubbotto antiproiettile, gli occhi al riparo dietro la maschera di protezione e via dicendo, Billy è andato da Shroom e gli ha chiesto come fai a non impazzire? Shroom ha annuito come se quella fosse una domanda estremamente ragionevole da porre, e gli ha raccontato di uno sciamano Inuit di cui aveva letto da qualche parte, che a quanto pareva era capace, soltanto guardandoti, di capire in che giorno saresti morto. E però non te lo diceva: lo considerava maleducato, un’intrusione in una faccenda di cui non aveva motivo di impicciarsi. Pensa quanto ti può mandare fuori di testa una cosa così, ha ridacchiato Shroom. Guardare quel vecchio negli occhi e sapere che lui sa.“Io non lo voglio mai incontrare”, ha detto Billy, ma Shroom si era fatto capire. Se una pallottola ti deve colpire, è già stata sparata.
Non si direbbe, ma questo è un libro che fa anche e soprattutto ridere. Ben Fountain, già autore della raccolta di racconti Fugaci incontri con Che Guevara (traduzione di Silvia Moschettone, Spartaco, 2011), firma un libro sensazionale e rimarchevole da ogni punto di vista, che l’anno scorso è stato trasposto al cinema da Ang Lee col titolo Billy Lynn – Un giorno da eroe (nel cast ci sono Steve Martin, Vin Diesel, Kristen Stewart tra gli altri) facendo un brevissimo passaggio nelle nostre disattente sale a febbraio. Fountain con una saldatura che forse possiamo fare risalire già all’antica Grecia usa lo sport per parlare di guerra.
I Bravo sono eroi di una guerra ripresa a tutto spiano e hanno sparato al nemico in favore di camera, rimbalzando di tg in tg ed ecco come e perché sono diventati famosi: ora sono di nuovo in patria per quello che è stato chiamato tronfiamente il «Victory Tour», una sequela di sbronze e strette di mano che ha il suo culmine oggi, al Texas Stadium, alla partita dei Dallas Cowboys.
Anche in È il tuo giorno Billy Lynn! il ritorno, vissuto come un bagno di folla nell’estasi brutale e primitiva della retorica, non potrebbe essere più contraddittorio: i ragazzi della Bravo sanno che dovranno tornare in Iraq e che il filo a cui è appesa la loro vita sarà di nuovo stressato e sfilacciato fino allo stremo; così si ubriacano e cercano di rifuggire i momenti di consapevolezza cieca in cui gli si palesa il loro destino tra un bicchiere – rigorosamente all’interno di un cartone di una bibita analcolica, bere sarebbe proibito in teoria – e un altro. Accolti come eroi dai connazionali rinfrancati e confermati nelle loro aspettative, nelle sicurezze che il mondo va in effetti come dovrebbe andare e che giustizia sarà fatta, e però col culo al caldo in panciolle davanti a Fox News. Tutti vogliono un pezzetto della Bravo, appena entrano in una sala è come se una scossa di corrente elettrica attraversasse le persone, che fiutano «l’odore di sangue». «Vorrebbe che almeno una volta qualcuno gli desse dell’infanticida, ma a quanto pare non viene in mente a nessuno il fatto che siano stati uccisi dei bambini. Invece parlano tutti di democrazia, sviluppo, armi di distruzione di massa.»
Tutto il libro si regge su un paio di fortunate meta-metafore: siamo immersi in un lunghissimo piano sequenza con Billy Lynn e la sua squadra all’interno del Texas Stadium, un impianto sterminato e però fatiscente, da ricostruire come la Nazione, dopo i liberatori attacchi dell’Undici settembre, con questi linoleum e moquette che a malapena celano le strutture cadenti e marce – un microcosmo che fatalmente si fa cosmo. Poi, il football americano: lo sport americano per eccellenza (c’è perfino il bisogno dell’aggettivo, non a caso) e lo sport guerresco per antonomasia. Uno sport – o meglio una messinscena per l’intrattenimento delle masse – noiosissimo, il cui vero contenuto si svolge sui maxischermi e non sul campo in erba sintetica, laddove si alternano a ripetizione gli spot riempitivi che dovrebbero colmare i due minuti di pausa per ogni trenta secondi di azione. La partita – questa guerra carnevalesca – non è che lo spot per gli spot, un simulacro perfetto dell’azienda Stati Uniti d’America: «a un certo punto non meglio identificato, l’America è diventata un gigantesco centro commerciale con una nazione accanto».
Negli spogliatoi, Billy si trova a illustrare il suo equipaggiamento e le sue armi a un gruppo di giocatori pompati come tori in procinto di officiare il rito sportivo della vestizione prima della battaglia, sportiva s’intende. E non si capisce bene quali siano i guerrieri, se i soldati o questi uomini inebetiti e dai fisici sovrumani, se l’attrezzatura militare siano i caschi, i paracosce, le ginocchiere e le conchiglie o gli M4 e le Beretta. Subito dopo, un sollecito magazziniere porta Billy e il sergente Dime nel sancta sanctorum del magazzino, stordendoli con l’«incubo di iperabbondanza» che sono gli Stati Uniti in cui si sono ritrovati catapultati. I giocatori «sono fra le creature più accudite nella storia del pianeta, godono della migliore alimentazione, delle più avanzate tecnologie, della più moderna assistenza sanitaria, vivono all’apice dell’innovazione e dell’abbondanza americane, il che fa nascere un pensiero sorprendente: mandateci loro, a combattere la guerra!».
Come sa ogni soldato, la paura è la madre di tutte le emozioni e «fare il soldato vuole anche dire accettare che il tuo corpo non ti appartiene», che è proprio lì, sulla pelle delle persone, che si combatte quella battaglia. A questo pensano, o meglio cercano di non pensare in tutti i modi Billy e i suoi mentre si avvicina il crescendo finale, che culminerà nello spettacolo all’intervallo con balli, canti, tamburi, bengala, fuochi, le Destiny’s Child e la Bravo nel mezzo. Un delirio da febbre che assume tinte parossistiche in cui Fountain dà il meglio di sé (per dare un’idea sembra di stare a guardare una roba come Crank in certi momenti).
5. Hassan Blasim, Il matto di piazza della Libertà, traduzione di Barbara Teresi, Il Sirente 2012

Francamente in una lista del genere, su una guerra combattuta soprattutto (ma non soltanto) da due paesi e però in una sola zona geografica, sarebbe insultante non inserire nemmeno un libro di uno scrittore iracheno, specie se consideriamo quanto americanocentrica sia stata la narrazione di questi anni di conflitto e come a pagare lo scotto – di quella che è stata storicamente e a tutti gli effetti un’invasione – sia stato soprattutto il popolo iracheno. Ma a prescindere da questioni che – appunto – prescindono dalla letteratura, Il matto di Piazza della Libertà è in questa lista per meriti squisitamente artistici.
Avete presente tutti quei video con una bandiera nera inneggiante alla jihad a fare da sfondo? Quelli in cui qualcuno invariabilmente finisce per essere sgozzato? Quelli che vengono trasmessi da al-Jazeera e poi rilanciati da tutti i media occidentali e non? Be’, a raccontare davanti alla telecamera tutte le nefandezze più efferate di volta in volta contro sciiti per conto degli americani, contro i curdi rinnegati o la popolazione civile irachena, o magari per cacciare l’esercito spagnolo dall’Iraq, è stato un uomo solo: un povero cristo che guidava un’ambulanza a Baghdad, che ora racconta la sua storia all’ambasciata di un paese straniero per ottenere l’asilo, o almeno un’insperata comprensione. Stesso attore protagonista, stesso regista, stessa troupe; anche lo scopo è lo stesso: creare il caos, il terrore. È così che la vede Hassan Blasim in L’archivio e la realtà. Siamo tutti complici, nessuno escluso. E badate che il tono è tutt’altro che ironico.
«In quegli anni una crudeltà abietta e animalesca, generata dalla paura di morire di fame, aveva preso il sopravvento. Io sentivo che stavo correndo il rischio di tramutarmi in un topo.»
In questo libro il mondo snuda i suoi «canini primitivi», come in Il camion per Berlino: contrabbandieri trasportano il bestiame umano verso i verdi (o presunti tali) pascoli dell’Occidente, trentaquattro persone finiscono per trasformarsi «in un grande impasto di carne, sangue e merda» in uno scioglimento in cui Blasim abbandona i territori del realismo, come spesso gli capita in questi racconti, per abbracciare una visione onirico-hobbesiana in cui l’uomo è lupo per l’altro uomo.
Un morto narra la sua ascesa da modesto scribacchino di resoconti della guerra tra Iran e Iraq a ministro della cultura, alle spalle di tutti i soldati morti, che non perdono occasione di ricordargli la natura truffaldina della sua carriera. Baghdad, 2006: il cadavere di un uomo viene rinvenuto con tre dita mozzate e una bottiglia d’alcol conficcata nel didietro, non è un infame traduttore per gli americani e nemmeno la vittima della violenza settaria che infiamma la città, ma qualcuno che si era macchiato di un delitto abominevole. Micce cortissime e risse sanguinose tra sudanesi e iracheni in un centro d’accoglienza italiano quando viene rovesciata la statua di Saddam. E poi ci sono: un matto con una cintura esplosiva a piazza della Libertà; un suonatore di liuto che passa dalla gloria degli inni patriottici e guerrafondai a incidere canzoni blasfeme; l’immigrato in Olanda che vuole diventare più olandese degli olandesi e finisce per ammattire; un uomo che una mattina si ritrova stampato in faccia un sorriso perenne e deve imparare a convivere con quella che ha tutta l’aria di una condanna; un migrante che nella sua inseparabile valigia nera ha le ossa della madre. Ma anche il vademecum di un esperto su come farsi strada nel mondo ballardiano delle «mostre di cadaveri» e allestire la propria, prima fondamentale galleria in questa specialità.
Sono short stories crude e amare, ma non potrebbe essere altrimenti, per uno scrittore che ha dovuto abbandonare l’Iraq e riparare in Finlandia. Ma dentro ci si trova anche molto altro, oltre alla diaspora irachena, la follia soprattutto. C’è qualche ingenuità e qualche ammicco al pubblico occidentale, come nella telefonatissima menzione alle Mille e una notte, e alla pedante tirata sulla condizione femminile in Iraq per esempio, con dei passaggi nondimeno brutali come questo:
La donna, nell’immaginario maschile comune, è considerata come una vagina, un sedere e un paio di tette, un appetitoso ammasso di carne fatto per scopare e cucinare, e il fatto che possa farsi esplodere è visto dagli uomini come un affronto alla loro virilità. Se non che, persino le carni dilaniate di una donna possono dare adito a scherzi e battute volte a titillare il membro maschile. Un giorno Hamràny aveva sentito una battuta merdosa del pasticcere, che raccontava di un suo amico che faceva il pescivendolo in un altro mercato e aveva ritrovato in mezzo al pesce la fica di una kamikaze che quel giorno si era fatta saltare in aria usando una cintura carica di esplosivo. La moglie del pescivendolo, quando l’uomo rincasò con la merce invenduta, si imbatté in quella fica e chiese al marito una spiegazione logica: cosa ci faceva la fica di una giovane donna in mezzo al pesce?
O ancora, riflessioni sugli scrittori e la scrittura in un paese di «morti di fame, assassini, analfabeti, soldati, paesani, vagabondi, gente che prega e gente oppressa». Tra gli scrittori citati ci sono Kafka, Camus, ma anche Carlos Fuentes (che diventa l’alter ego di un migrante) e Béla Hamvas, ma lo stesso Hassan Blasim fa la sua comparsa in uno dei racconti come metanarratore nella più classica tradizione araba. Khaled al-Hamràny, uno scrittore, è addirittura il personaggio di uno dei racconti, Il mercato delle storie: per tutta la vita ha scritto solo e soltanto del mercato rionale vicino casa sua e a cinquantasette anni sarà proprio lì che morirà in un attentato.
Una lettura non per tutti i palati, spesso greve e macabra, con accenti allucinati fatti di «deliri primitivi, tribali, che tentano di nascondersi dietro un’inutile, sanguinosa risata» e una visione della natura umana e non in cui l’uomo è la minaccia. Siamo tutti dei topi kafkiani che di notte hanno incubi popolati di gatti terribilmente affamati e ghiotti.




14 Comments