Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Country Zeb.
Qualche tempo fa, in una delle mie sempre più rare apparizioni su Facebook, ho scritto questa frase: «A volte la cosa nuova da fare è fare la stessa cosa». Ho ricevuto cinque mi piace, due dei quali da amici che non parlano italiano: un vietnamita e un pakistano e ancora oggi mi chiedo come sia stata tradotta la mia frase nelle loro rispettive lingue dall’algoritmo di Facebook. Quella frase però, e il pensiero che l’ha generata, mi era subito sembrata perfettamente calzante con lo stato d’animo in cui mi trovavo in quel momento. Nel corso della mia vita ho sempre cercato di tenermi il più lontano possibile dalla routine. Ho sempre dato valore al cambiare abitudini e idea, pronto a fare cose diverse e a nutrirmi dell’adrenalina che deriva dal cacciarsi in situazioni nuove, anche soltanto per il gusto di scoprire come ne sarei uscito. Se ne sarei uscito. E invece, quella sera, con il cielo di Dicembre che minacciava neve e il riflesso del camino acceso sulle finestre, ho pensato che fare la stessa cosa fosse un ottimo modo per fare qualcosa di di diverso.
Poi a Marzo ho ascoltato Carrère.
L’occasione dell’incontro era la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore francese, Propizio è avere ove recarsi (Adelphi, 2017, traduzione di Francesco Bergamasco), una raccolta di articoli e brevi saggi scritti negli ultimi 25 anni; un’introduzione all’opera di Carrère nella quale, chi già conosce lo scrittore, ritroverà molte delle storie sviluppate nei suoi libri.

La conferenza è all’interno della rassegna LibriCome presso l’Auditorium di Roma. Sala Petrassi al completo e Sandro Veronesi sul palco a dialogare con Emmanuel Carrère. Veronesi aveva preparato delle domande ma, almeno nella prima parte della conferenza, sembra più interessato a parlare che ad ascoltare. Il pubblico se ne accorge e rumoreggia.
Le prime battute dell’incontro sono dedicate a due delle loro opere più recenti: Non dirlo – Il Vangelo di Marco (Bompiani, 2015) di Veronesi e Il Regno (Adelphi, 2015, traduzione di Francesco Bergamasco) di Carrère. Dopo essere stato cristiano per un breve periodo della propria vita, Carrère decide di ripercorrere i sentieri del Nuovo Testamento: non da credente, bensì «da investigatore» in linea con la sua vera natura di scrittore. Durante la conferenza Carrère ribadisce di sentirsi innanzitutto un documentarista e non un romanziere. Anzi, un ritrattista, come sottolineato anche in un commento apparso su Le Monde: «Carrère fa molto di più che raccontare: trasforma il mondo in letteratura. Come un grande ritrattista, dipinge molto di più che il riflesso esatto di una persona o di una situazione: dipinge la sua verità».
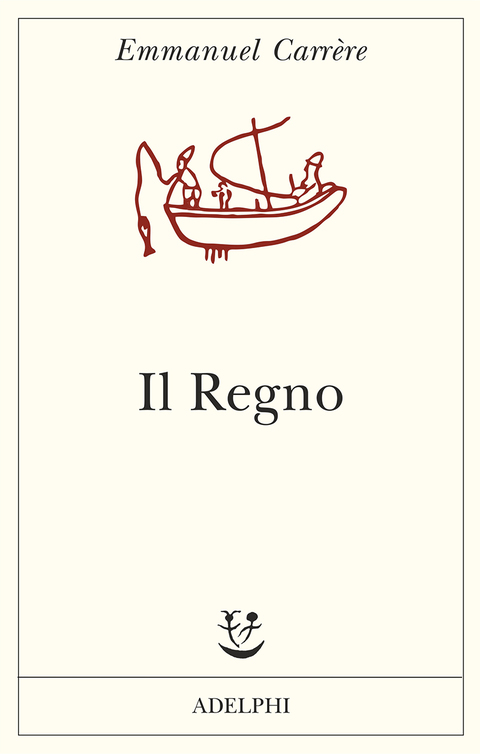
Sul palco i due scrittori ironizzano sul fatto che Carrère, il documentarista, abbia deciso di dare voce all’evangelista Luca, il più romanziere fra i quattro. Veronesi, viceversa, si è immerso nel testo di Marco, il Vangelo d’azione, il primo, il più breve. Il Vangelo di Marco è, nel racconto di Veronesi, «una raffinata macchina da conversione, sintonizzata sull’immaginario dei suoi destinatari e per questo più simile ai film di Tarantino che ai testi con i quali gli altri evangelisti raccontano la stessa storia». «Marco» continua Veronesi «è come se avesse scritto una sceneggiatura di Sergio Leone, comincia direttamente con l’azione, con Giovanni Battista, con un eroe nel pieno della sua funzione.»
La vastità di temi e personaggi che popolano i libri di Carrère facilitano il dialogo. Uno dopo l’altro vengono affrontati tutti i temi più cari allo scrittore: dal Romand de L’Avversario (Adelphi, 2013) ai suoi reportage nell’est Europa, dai casi di cronaca (e l’influenza che Capote ha avuto su di lui) al suo rivendicare la propria essenza di bobo (bourgeoise bohemien), ed è quindi inevitabile che prima che la conferenza si concluda, si arrivi a L’uomo dei dadi.
La storia è questa.
«Verso la fine degli anni sessanta Luke Rhinehart faceva lo psicoanalista a New York e si annoiava. Abitava in un bell’appartamento con una splendida vista sulle finestre dei vicini, che a loro volta avevano una splendida vista sulle sue finestre. […] Così va la vita di Luke, tranquilla e monotona, fino al giorno in cui, dopo una serata un po’ troppo alcolica, trova sulla moquette un dado, un banale dado da gioco, e gli viene l’idea di lanciarlo e di agire in base al risultato. “Se esce una cifra tra due e sei faccio quello che farei comunque: riportare i bicchieri sporchi in cucina, lavarmi i denti, prendere due aspirine per non avere troppo mal di testa al risveglio, infilarmi a letto accanto a mia moglie che dorme e forse masturbarmi di nascosto pensando ad Arlene. Se invece esce l’uno, faccio quello che ho veramente voglia di fare: attraverso il pianerottolo, busso alla porta di Arlene, che stasera so che è sola a casa, e ci vado a letto” […].»
Da quel momento la vita di Luke cambia in modo radicale (è uscito l’uno e in camera di Arlene ci è andato veramente). Il dado diventa il suo oracolo, a lui affida ogni decisione della sua vita e gradualmente, ma senza mai guardare indietro, sprofonda nel baratro di una vita vissuta seguendo regole dettate esclusivamente dal caso. Sì perché la prima regola è che bisogna sempre obbedire, sempre applicare la decisione del dado. Ma obbedire al dado significa in fin dei conti obbedire a se stesso, perché è colui che lancia il dado a stabilire le opzioni.
L’assunto teorico sembra un’esasperazione delle teorie freudiane: Luke descrive la mente umana come un’accozzaglia di pulsioni in contrasto tra loro, imbrigliate dalla vita in società. L’unico modo affinché l’uomo realizzi se stesso è sfogare ogni pulsione, anche la più perversa, senza ascoltare il proprio ego sociale. Si tratta di uccidere la personalità, insomma, e il modo migliore per farlo è vivere a caso.(( L’uomo dei dadi – Sugarpulp))
Seguendo un canone consolidato, ogni qualvolta Carrère intuisce che ci potrebbe essere una storia interessante da raccontare, prende e parte, si immerge nella storia e nei limiti del possibile cerca di viverla lui stesso. Carrère aveva letto L’uomo dei dadi a sedici anni e per qualche tempo era andato in giro con un dado in tasca, facendovi affidamento per trovare la sicurezza che gli mancava con le ragazze, ma già allora si era domandato che tipo di uomo avesse potuto scrivere quel libro: Luke Rhinehart era il nome del protagonista ma anche l’autore di quella storia folle .
Qualche decennio dopo, le stesse domande tornano ad assillarlo: cosa c’è di vero in quella storia? Chi è Luke Rhinehart? Che fine ha fatto?
Seguendo una serie di indizi che gli faranno scoprire anche l’esistenza di comunità di adepti del dado, Carrère riesce a risalire all’identità dell’autore e a incontrarlo. Luke Rhinehart è in realtà lo pseudonimo di George Cockcroft e Carrère rimarrà in parte deluso, o quanto meno sorpreso, quando si troverà di fronte un anziano signore, banalmente normale, sposato da cinquantasei anni e ancora innamorato di sua moglie.
La storia di quell’incontro è diventato un articolo pubblicato sulla rivista francese XXI nel 2014((Internazionale ha ripreso e tradotto l’articolo nel 2015. Lo stesso pezzo è contenuto in Propizio è avere ove recarsi. In Italia, Marcos y Marcos ha pubblicato L’uomo dei dadi nel 2004.)) e nelle ultime battute Carrère riporta una frase di George Cockcroft che mi ha fatto pensare alla mia idea sul fare o non fare la stessa cosa. Queste le sue parole: «Non c’è nulla di male nel fare sempre più o meno le stesse cose. Il punto è capire se vi piace. La maggior parte delle persone, purtroppo, non amano quello che fanno né quello che sono. È pensando a loro che ho scritto tutte quelle cose sul dado».
La conferenza è terminata, Carrère lascia il palco e io mi rendo conto di aver avuto una piccola folgorazione. Uno di quei momenti tanto cari a noi lettori: non vedevo l’ora di mettermi a leggere tutto ciò che Carrère ha scritto. La stessa sensazione (giusto per citarne due tra le più forti) che avevo provato con Houellebecq e Philip Roth.
Alla libreria dell’auditorium compro Propizio è avere ove recarsi, un bel mattone azzurro-Adelphi con in copertina il volto ammaliante del francese. Di fianco alle casse parte la fila, già consistente, dei lettori adulatori in attesa di farsi fare uno scarabocchio sulla prima pagina e di andare a raccontare agli amici che Carrère mi ha sorriso!. No grazie, non fa per me. Mi sembra incredibile che resista ancora la tradizione del firma copie. Io piuttosto mi affretto a raggiungere casa per poter iniziare a leggere.
La verità è che io di Carrère avevo letto ben poco. Ero rimasto a lungo a cullare un’attrazione a pelle per lo scrittore, per il suo modo di interpretare la scrittura, sempre legato a corda doppia con il reale (non a caso un altro dei miei autori preferiti è Geoff Dyer). Avevo divorato L’Avversario, un libro che mi ha lasciato completamente incapace di reagire, tanto meno di scriverne – meglio di me ha fatto Marco Montanaro in questo breve ma significativo pezzo su Malesangue. E poi molte recensioni e saggi critici, come per esempio questo ebook di Luigi Grazioli edito da doppiozero.
Ma insomma il duello one-to-one con lo scrittore doveva ancora iniziare. E allora, mentre giacevo imbottigliato nel traffico del sabato sera sul Lungo Tevere, ecco l’idea di fare qualcosa di diverso: quale miglior metodo del gioco dei dadi per tuffarmi finalmente e nuotare tra le pagine di Carrère? Certo, per quanto la prima regola del gioco dei dadi escluda la possibilità di tirarsi indietro, nel mio caso sapevo che, comunque fosse andata, non sarei rimasto deluso. Queste le opzioni: I – Il Regno, II – Limonov, III – Vite che non sono la mia, IV – La vita come un romanzo russo, V – rileggere L’Avversario e, giusto per aggiungere un elemento di rischio, VI – dimenticarmi di Carrère e leggere altro.
Tiro il dado. Si ferma sul due.
Meno di ventiquattrore dopo apro Facebook e posto una foto del libro posizionato davanti al camino acceso con le fiamme sullo sfondo che sembrano bruciare la copertina: «Limonov, è giunta la tua ora. E scusa il ritardo».
Se n’è già scritto tantissimo ed era stata proprio quell’inondazione di recensioni entusiaste e critiche positive a tenermi a debita distanza dal duo Carrère-Limonov. Ora però non posso che accodarmi e ammettere che avevate ragione.
Come riassume Carrère fin da principio, Eduard Savenko (lo pseudonimo Limonov deriva sia da limon, limone, omaggio al suo umore acido e bellicoso, sia da limonka, che significa bomba a mano) è stato «teppista in Ucraina, idolo dell’underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso, nell’immenso bordello del dopo comunismo, vecchio capo carismatico di un partito di giovani desperado».
Il romanzo tradotto sempre da Francesco Bergamasco si apre subito con un ritmo incalzante perché è la vita di Limonov a non aver avuto tregua La sua storia è piena di cadute e di risalite, di successi e fallimenti, mosse azzardate (e spesso discutibili) che Carrère riporta senza lesinare dettagli. Già dopo le prime pagine viene da chiedersi: ad essere avvincente, coinvolgente, struggente è il romanzo di Carrère o la vita di Limonov? Tutte due, direi. Il tipico caso in cui uno più uno fa tre.
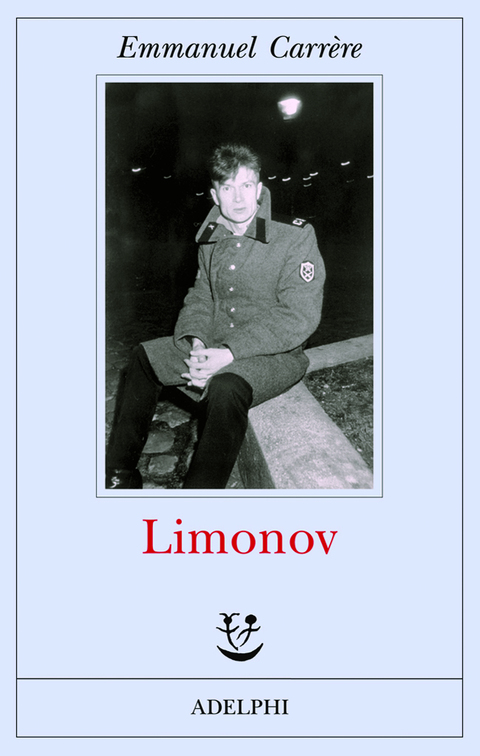
Proseguendo con la lettura ho evitato che la mia mente si perdesse in qualsiasi considerazione di tipo morale sul personaggio. Molti, ho letto, ritengono Limonov una persona insopportabile, un esaltato, un pazzo. Ma sono proprio queste cose che fanno di lui un incredibile personaggio letterario. L’eccessiva presenza di Carrère, dicono altri. E io rispondo ancora di no (a parte forse una decina di pagine all’inizio del periodo parigino) perché è proprio quel suo entrare e uscire dalla vicenda a ricordarci che non stiamo parlando di un personaggio inventato ma di un uomo in carne ed ossa, ancora vivo.
La mia attenzione si è soffermata invece su questioni artigianali. Cercavo di capire come Carrère fosse riuscito a creare un collage così omogeneo e avvincente partendo dai molti elementi a sua disposizione: i libri dello stesso Limonov, qualche incontro nel corso degli anni, una lunga intervista in fase di stesura del libro e dialoghi con chi l’ha conosciuto. È (anche) questo lavoro da artigiano che mi ha conquistato, il lavoro di montaggio e la manualità nel trasformare la realtà in letteratura.
D’altronde, leggendo Carrère si capisce che quel modo di scrivere è esattamente ciò che sa fare meglio e che ama di più. Come lui stesso afferma: «[…] mi sono messo a scrivere libri che spesso ruotano intorno alla tentazione delle vite molteplici. Noi tutti siamo prigionieri della nostra personcina, limitati nei nostri modi di pensare e di agire. Vorremmo sapere cosa significa essere qualcun altro, io almeno vorrei saperlo, e se sono diventato scrittore è in gran parte per immaginarlo. È questo che mi ha spinto a raccontare la vita di Jean-Claude Romand, che ha passato vent’anni a fingere di essere qualcun altro, o di Eduard Limonov, che di vite ne ha vissute dieci».
Forse anche a Limonov sarebbe piaciuto il gioco del dado. Di certo non si sarebbe tirato indietro e avrebbe fatto a gara per aggiungere opzioni sempre più estreme. La verità è che nella vita di Limonov c’è stato ben poco di casuale. Si è spostato dalla periferia Ucraina a Mosca, da New York a Parigi, nei balcani e poi di nuovo in Russia. Ogni spostamento dettato dalla ricerca di nuove esperienze, nuove boccate di vita della quale non aveva mai abbastanza. Un continuo reinventarsi ogni volta che sentiva di non aver più niente da imparare o da combattere. Ogni sua azione, in sostanza, aveva un unico obiettivo: tirarsi fuori dal grigiore e dalla povertà della sua infanzia in Ucraina, avere successo e diventare famoso. Morire, magari, ma da eroe, non da milite ignoto.
Il successo Limonov lo otterrà, prima come idolo culturale e poi come scrittore. Ai soldi non ha mai dato troppa importanza. Ha vissuto a lungo in stanze anonime e spoglie, se non addirittura in strada, mantenendo un atteggiamento stoico ai limiti dell’autolesionismo. Uno stile vita quasi ascetico, come un monaco votato a una religione personale che ha creato a sua immagine e somiglianza. Il successo dei suoi libri è infatti il riflesso del suo essere Limonov. I suoi scritti non sono mai di finzione, ma sempre e solo autobiografici, resoconti di vita vissuta, perché Limonov è capace soltanto di raccontare se stesso, essendo la sua stessa esistenza la sua massima invenzione, la sua opera maggiore.
Quando Limonov sta per compiere cinquant’anni, il nuovo gioco da provare è la guerra. Limonov pensa che sia un’esperienza che un uomo prima o poi deve fare (per il gusto di vedere come se ne esce, se se ne esce?). E lui è pronto. Si butta in mezzo al calderone incomprensibile della guerra dei Balcani negli anni novanta, prima come curioso, poi come giornalista e infine imbracciando le armi. E questo è il punto in cui il suo atipico biografo francese ha un momento di crisi. Carrère è in difficoltà, si ferma, per un anno non riesce più a scrivere. Sembra quasi che il personaggio del suo romanzo gli stia sfuggendo di mano. Forse è troppo vero? Quando un documentario trasmesso dalla televisione francese ritrae Limonov mentre armeggia con una mitragliatrice sulle colline sopra Sarajevo, come farebbe un bambino alle prese col suo nuovo giocattolo, Carrère si domanda se Limonov abbia mai ucciso. Sicuramente lo ritiene capace, ma a far interrompere la sua scrittura non è tanto la sua natura da potenziale omicida, quanto il suo essersi messo in ridicolo, come un ragazzino che si atteggia a duro in una sagra di paese. È questo – si domanda Carrère – l’uomo per il quale sto spendendo anni per scriverne la storia?
Limonov, per sua stessa definizione è un avventuriero che prova piacere a rovistare nelle interiora della storia, e così, dopo l’esperienza della guerra c’è la politica. Leggere la storia di Limonov vuol dire ripercorrere la storia della Russia negli ultimi sessant’anni. La storia della povertà crudele che colpisce sempre le stesse persone, che non cambia se al potere c’è il comunismo totalitario o quella nuova forma di democrazia che si sono inventati i Russi. Limonov ancora una volta vuole essere al centro dell’azione e il suo modo di farlo è fondare un suo movimento, il parito nazionalbolscevico. Avrà vita breve e scarso successo, Limonov verrà accusato di terrorismo, banda armata, detenzione di armi da fuoco e istigazione ad attività sovversive. Passerà quasi due anni in prigione.
Durante il periodo di lavori forzati nel carcere di Engel’s, Limonov ha un momento di illuminazione e sembra raggiungere una sorta di estasi. Grazie a un compagno di carcere, un delinquente buono e saggio, aveva imparato a riconoscere il valore della meditazione e alla fine ricorderà il carcere come il miglior periodo della sua vita.
Questo, per un romanziere, avrebbe potuto costituire un ottimo finale, ma Limonov è ancora vivo. Per uno come Limonov passato e futuro hanno poco senso, la sua vita è un continuo presente in divenire, un unico flusso. Limonov è uno vede nel proprio futuro «sia la possibilità di ricevere il Nobel, sia la possibilità di ricevere una pallottola in fronte dai suoi nemici». Se fosse soltanto il protagonista di un romanzo, l’autore potrebbe farlo uccidere o ancora meglio, farlo avvelenare, ma Limonov è ancora in piedi e quando Carrère, nelle ultime pagine del libro, ritorna alla lunga intervista che ha fatto a Limonov, riporta questo scambio: «E strano però» gli chiede Limonov «perché vuole scrivere un libro su di me?». «Perché ha (o ha avuto) una vita appassionante, romanzesca» risponde Carrère, «una vita che ha accettato il rischio di calarsi nella storia.» La risposta di Limonov lascia Carrère di sasso: «Già, una vita di merda».
Sono convinto che Carrère riscriverebbe ogni singola riga del suo libro, così come Limonov rivivrebbe ogni singola giornata della sua vita. E a noi lettori cosa rimane oltre allo scombussolamento derivato dal viaggio al fianco di Limonov? Carrère raccoglie le testimonianze di chi gli ha vissuto accanto e il giudizio è unanime, he is a very decent man. Limonov non ha mai sprecato un’ora della sua vita, pur nelle sue scelte a volte discutibili non si è mai tirato indietro e ha sempre mantenuto quella lealtà da duri, quel patto d’onore di non tradire la parola data, quella forza di cadere e sapersi sempre rialzare. Non so se Limonov sia mai stato felice, forse è una condizione che neanche gli interessa. Forse la sua unica aspirazione è sempre stata di dimostrare, soprattutto a se stesso, che era vivo e la sua unica missione di combattere la massa di persone che, seppur vive, sono morte dentro.
Lascerò sedimentare il polverone che si è alzato nella mia mente leggendo Limonov. Forse aspetterò un po’ di tempo prima di leggere un altro Carrère e quando lo farò non avrò certo bisogno di tirare il dado. Ora, mentre scrivo queste ultime righe torno su Facebook. Cerco Limonov e lo trovo. In questi giorni sembra stia scrivendo parecchio, in russo, e allora questa volta sarò io a dovermi fidare dell’algoritmo di traduzione.




13 Comments