Tra le manie dei lettori, una mi è particolarmente cara: legare libri a destinazioni mentali e geografiche. A volte è la lettura a stimolare il viaggio, a volte capita l’opposto. Per assecondare l’ossessione, due giorni prima della partenza ho terminato The Great Clod: Notes and Memoirs on Nature and History in East Asia, una raccolta di saggi di Gary Snyder, alcuni pubblicati quarant’anni fa, altri inediti, come il pezzo che apre il libro: Summer in Hokkaido.
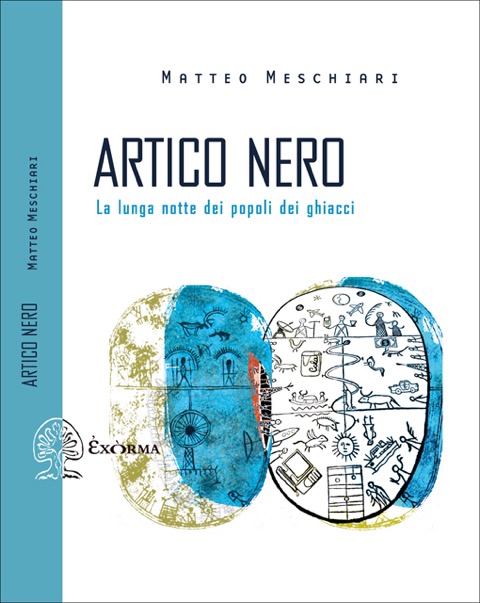
Snyder ha vissuto in Giappone per oltre dieci anni, senza tuttavia spingersi fino all’isola più a Nord. Nel 1969 ricevette la richiesta di scrivere un pezzo sulle questioni ambientali in Hokkaido e su ciò che rimaneva delle popolazioni indigene di quelle terre, gli Ainu. L’idea era di raccogliere testimonianze da usare come munizioni per combattere il piano di sviluppo dell’area di Sapporo che in quegli anni si stava preparando a ospitare l’XI edizione dei Giochi Olimpici Invernali.
Le cose andarono diversamente: la Summer in Hokkaido di Snyder è stata quella del 1972 e a quel punto le Olimpiadi erano già state disputate. L’area intorno a Sapporo è stata sviluppata con grandi investimenti e quell’edizione delle olimpiadi invernali, le prime al di fuori dell’Europa, vengono ricordate come un successo.

Foto di Marco Piazza
Quasi mezzo secolo più tardi atterro a Sapporo in una giornata grigia e piovosa. Subito mi lascio alle spalle l’area urbana per addentrarmi nei boschi di abeti e betulle e raggiungo una vecchia stazione termale sulle sponde del lago Shikotsu. Mi accoglie l’odore di un turismo che fatica a stare al passo coi tempi, la moquette usurata, i corrimano lisci e incurvati. La notte arriva presto e prima di dormire mi immergo nella vasca di acqua bollente all’aperto. Guardo il cielo nero che si riempie di stelle e sento che è il momento di iniziare l’unico libro che mi ero portato in valigia: Artico nero di Matteo Meschiari – Exòrma edizioni, 2016.
Definito dallo stesso autore come un romanzo corale, il libro si sviluppa in sette storie etnografiche narrate con uno stile eterogeneo. Racconti, poesie, ricordi, citazioni, liste di parole e note. Chiudo gli occhi e vedo l’antropologo che prende appunti su quaderni di campo, piccoli segni per non dimenticare i volti segnati dal freddo e i paesaggi ruvidi. E poi di notte, quando i fotogrammi del giorno passato si srotolano nella mente, poche immagini sono ancora a fuoco, le più forti, le più dolorose.

Foto di Marco Piazza
Meschiari ci accompagna in un viaggio di salti geografici, temporali e narrativi. A volte confonde il lettore, forse di proposito. Certamente lo scuote con un ritmo serrato e un linguaggio diretto e feroce come le storie che racconta. Una miriade di aneddoti e dettagli aprono strade per ulteriori approfondimenti ma l’autore non si limita a raccontare o trascrivere storie, ce le scaraventa in faccia. Sono le storie di popoli circumpolari come i Sami, gli Inuit, rapiti e stuprati dagli esploratori dell’ottocento. Popoli avvelenati e storditi dall’alcol, confinati in isole di terra e scatole di lamiera, avvelenati con lo zucchero, esposti in musei e fatti sfilare come burattini.
Il mio viaggio nella terra di vulcani, laghi e boschi continua verso Sud. Dove sono gli Ainu? Lungo le coste bagnate dal mare nordico e severo, piccoli agglomerati di case sorgono all’improvviso. Paesi disabitati, o quasi. Pochi i turisti nei porticcioli a scattare foto ai pescherecci e nelle locande a mangiare riso e ricci di mare. C’è un’atmosfera da ultima frontiera. Di Ainu non c’è quasi traccia. Case di paglia nel museo di Shiraoi, utensili conservati in bacheca e balletti folcloristici. Il processo di assimilazione, iniziato fin dal periodo Meiji, può considerarsi portato a termine con successo. Difficile trovare quelle voci che Meschiari insegue con tenacia nel suo Artico Nero. L’antropologia, la sociologia, la geografia culturale – afferma Meschiari – usano troppi plurali. E allora lui prova a parlare al singolare, ad ascoltare e riportare le voci dei protagonisti. Lo fa con la consapevolezza che «non appena iniziamo a raccontare, stiamo già alterando la realtà, stiamo già inventando. Io non cerco la verità, mi interessa l’intensità. Ovviamente provo a dire la verità, ma provo a dirla in un modo che è già invenzione. E la verità è di un Artico nero e morente».

Foto di Marco Piazza
Infondo è sempre la medesima storia che si ripete, quel conflitto ancestrale fra Caino, l’agricoltore e Abele, il pastore. Un contrasto che si è ripetuto nei secoli. «Agricoltori-allevatori (sedentari) contro cacciatori-raccoglitori (nomadi), due antropologie, due universi culturali e ideologici che nella storia del mondo sono sempre entrati in collisione. Da un lato le società gerarchiche, guerriere, che accumulano beni, dall’altro le comunità anarco-comuniste, tendenzialmente miti, ecologicamente integrate.»
La storia di popoli civilizzati che per portare il proprio credo culturale, religioso e politico avvelenano tutto ciò che trovano sul loro cammino: persone, territori, identità, mitologie. Non è un caso che fra le popolazioni che vivono nell’Artico si registra il più alto tasso di suicidi fra i minorenni.
L’annientamento dell’identità uccide più di un proiettile. Comunità smembrate, tradizioni cancellate. Cosa rimane della loro visione animistica dell’esistenza? Della loro mitologia in cui figure umane si confondono tra realtà e mito e diventano animali, balene, caribù?

Foto di Marco Piazza
Leggo tristezza nei racconti di Artico Nero. Desolazione più che rabbia, rassegnazione forse. Impotenza. Lo stesso generale senso di abbandono e povertà (seppur ben mascherato) che mi sembra di scorgere lungo le coste di Shakotan. Scogliere aspre e tetti cadenti. Ruggine. È forte il contrasto con il mio bagaglio di immagini del Giappone, di scale mobili, grattacieli e luci al neon nelle notti di Tokyo, Kobe, Osaka.
Verso la fine del libro Meschiari ci invita a fare un esercizio: trascrivere nomi di popoli e toponimi e poi leggerli, come un mantra o una preghiera laica. Questo gesto apparentemente inutile trova la sua giustificazione nel fatto che alla fine ci resta solo l’immaginazione per capire come doveva essere prima. L’autore compila la sua lista «per ricordare ciò che non conosco, per immaginare ciò che non so».
Lo faccio anche io, davanti a una mappa del circolo artico disegnata sul pavimento all’ingresso del museo degli Ainu a Shiraoi. Una mappa che indica un senso di fratellanza fra i popoli dell’Artico. Allora mi siedo e ricopio i nomi e lungo la schiena sento nascere un rivolo di acqua ghiacciata:
Sami, Nenets, Enets, Iroquoi Indians, Algonquian Indians, Athabaskan Indians, Inuit, Aleut, Sioux Indians, Chukchi, Yakut, Yukagir, Koryak, Itel’men, Even, Ul’chi, Negidal, Nivkhi, Uilta, Evenki, Nanai, Udekhe, Orochi, Burvat.
Persone e popoli con una storia che nessuno ricorderà.
Scrivo queste ultime righe sull’aereo che mi riporta in Italia. Nel 2020 ci saranno le Olimpiadi a Tokyo ed è notizia di questi giorni che il governo giapponese sta finalizzando la procedura per riconoscere lo status di Indigenous population (secondo le direttive delle Nazioni Unite) alle poche migliaia di Ainu rimasti. Si tratta di un ultimo tassello nel percorso per preservare la loro identità e riconoscere la loro lingua e religione. Sembra che il governo stia anche pianificando l’apertura di strutture per promuovere la cultura Ainu in occasione delle Olimpiadi. Immagino sia una cosa positiva, immagino sia meglio che vederli soltanto sfilare come burattini durante la cerimonia di apertura.
Ricordare, sembra essere questa la parola chiave, se proprio non si riesce a fare altro. E allora leggiamo tutti le storie di Artico Nero. Continuiamo a parlarne. Senza morale – come sottolinea Meschiari – tranne una: il ghiaccio si sta sciogliendo.




22 Comments