Nelle ultime settimane si sono succeduti articoli su articoli anche contraddittori fra loro sulle «nuove» mode editoriali: sull’Espresso Lara Crinò parla della nuova letteratura africana mentre sul Libraio Antonio Prudenzano di «tendenza Asia in libreria». È indubbio che negli ultimi anni in molti fra editor e scout si siano prodigati in una caccia alla nuova Chimamanda Ngozi Adichie, producendo talvolta risultati al limite del patetico, ma avendo il merito incredibile di aprire uno spiraglio su un’area geografica che fino a Metà di un sole giallo passava largamente sotto i radar di stampa e pubblico. È finalmente diventato normale e non più pionieristico (anche grazie ai pionieri) vedere testi di autori e autrici africani in libreria e il nostro riferimento per i libri sul continente non è più Karen Blixen (la sua Africa è appunto «sua» in senso strettamente coloniale) o, peggio mi sento, la retorica terzanista-terzomondista à la Dibba. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: La nave di Teseo ha varato la collana Oceani con Soyinka e Achebe, 66thand2nd pubblica Noo Saro-Wiwa, A. Igoni Barrett e Alain Mabanckou per tacere degli altri, e perfino un editore meno di ricerca come Garzanti ha il merito di portare in Italia e pubblicare Yaa Gyasi, un’autrice statunitense nata in Ghana, sebbene vincolandola a un titolo che fa un po’ manuale di auto-aiuto come Non dimenticare chi sei (l’originale è il ben più calzante Homegoing) e a una copertina anni ’80 abbastanza rivedibile.
Yaa Gyasi arriva in Italia sulla scorta di recensioni stellate, blurb importanti come quelli di Ta-Nehisi Coates e di Petina Gappah, un anticipo a sette cifre e soprattutto – tra gli altri premi – il PEN/Hemingway per la miglior opera prima.
Non dimenticare chi sei è una miniera di storie e ogni capitolo potrebbe essere letto come una narrazione a se stante, il che lascia intuire un paio di domande: dove comincia la nostra storia e in che rapporto quel segmento di tempo che ci è concesso è formato e messo in discussione – e forse anche disgregato – dal rapporto con gli altri e con le loro storie, ammesso che si possa scinderle dalle nostre?
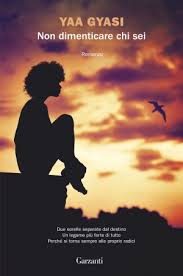
«Non dimenticare chi sei» di Yaa Gyasi, traduzione di Valeria Bastia, Garzanti
«La storia racconta storie» come fa dire a uno dei suoi personaggi Gyasi e dobbiamo affidarci e farci guidare dalle sue parole per osservare le trasformazioni immani che si succedono dal crinale del Settecento fino ai giorni nostri attraverso le voci dei morti giustapposte una all’altra. Ribaltando il cliché editoriale, questo è un romanzo che potrebbe essere letto come una raccolta di racconti, magari di quelle molto omogenee in cui le singole narrazioni sono autonome ma si inseriscono in un tutto più grande della loro gittata. Perché in fondo tutta la questione formale sta qui: cosa sono il racconto, la poesia, il romanzo se non una diversa dimensione e amministrazione del tempo?
La struttura di questo romanzo è enunciata fin dal principio: quasi fosse un romanzo russo, c’è un albero genealogico da cui si diramano due rami fitti di nomi. Due sorelle e un bivio, per dirla con Enrico Ruggeri, una biforcazione della storia e della Storia che porta una delle due e la sua progenie negli Stati Uniti come schiava nelle piantagioni di cotone dopo un viaggio nella Grande Nave sull’Atlantico e l’altra, che va in sposa suo malgrado a un soldato inglese, a rimanere in Ghana e a subire le vicissitudini e gli strascichi del colonialismo. Due destini strappati alla loro terra, ma cuciti a doppio filo anche con l’oceano di mezzo a separarli.
L’affabulazione e la capacità di rinnovare quel meccanismo virtuoso per cui il lettore è continuamente in grado di tracciare la storia all’indietro e nondimeno sempre all’erta in attesa di nuovi squassi della trama (ebbene sì, un grande ritorno su questi schermi) sono il punto forte di Yaa Gyasi. Non c’è un ghirigoro che sia uno rintracciabile nel libro e nemmeno l’ombra di velleità postpostmoderne, men che meno una riflessione metaletteraria o un romanzo nel romanzo.
Attraversando le generazioni, il romanzo passa in mezzo alla cruna di tre guerre: quella civile americana, quella tra gli ashanti e i fanti, e quella d’indipendenza degli ashanti contro gli inglesi; ma soprattutto si muove in una direzione che collega le Americhe e l’Africa, Harlem e Jackson, Mississippi con Accra e Kumasi: quella della tratta degli schiavi.
C’è una grande fortezza commerciale di un bianco coloniale – non a caso – «il Castello», in cui la menzione involontaria a Kafka forse per una volta non è del tutto a sproposito, e da qui passano gli schiavi: ultima meta di un viaggio senza ritorno, rinchiusi in condizioni immonde, sono in attesa di finire in Giamaica, negli Stati Uniti o a Aburokyire. È un mercimonio umano in cui tutti si macchiano di qualche colpa. I negrieri ashanti razziano i villaggi confinanti con il loro territorio e portano i prigionieri agli intermediari fanti, ewe o ga che poi li rivendono agli inglesi, agli olandesi o a chiunque paghi meglio.
Effia e Esi, figlie della stessa madre Maame, sono sorellastre; crescono in due gruppi etnici e in due villaggi diversi, Effia tra i fanti e Esi con gli ashanti, senza sapere l’una dell’altra. Il loro fato – perché deciso dagli altri, dalla tradizione e da una concatenazione di eventi in cui loro sono solo un ingranaggio – sarà segnato nel caso di Effia da un matrimonio col governatore del Castello, James Collins, e farà sì che suo figlio studi in Inghilterra, e nel caso di Esi dall’aver provato compassione nei confronti della schiava di casa, mettendo così in moto inavvertitamente la macchina che la porterà a essere catturata e ridotta in schiavitù lei stessa.
Ma prescindendo da plot e struttura, questo è anche un libro che vuole regolare i conti con la verità storica e su come essa venga costruita. «Avevano imparato che in realtà una storia non era altro se non una bugia mai scoperta» e il punto di una storia – che sia o meno con la esse maiuscola ogni storia possibile in quella terra va a sbattere con un dato imprescindibile – non è nemmeno lo schiavismo, ma «a chi appartiene la terra, i suoi abitanti, il potere. Non puoi conficcare un coltello in una capra e poi limitarti a estrarlo lentamente, sperando che vada tutto liscio senza versare sangue. Impossibile». Non ci si affranca mai dall’oppressione e, anzi, questa non smette mai di far valere le proprie catene e cicatrici: «Sarebbero solo cambiate le modalità, dai ceppi di ferro fissati a polsi e caviglie a pastoie di ben altro tipo, condizionamenti psicologici che attanagliano la mente. […] Quand’anche la tratta degli schiavi fosse terminata per sempre, gli inglesi non avevano nessuna intenzione di lasciare l’Africa». D’altronde, ci si può anche dire liberi ma non lo si è mai del tutto, proprio come Jo: «Sui documenti da uomo libero figurava come Kojo Freeman. Proprio così, un uomo libero di nome e di fatto. Metà degli ex schiavi di Baltimora avevano lo stesso cognome. A furia di ripeterle, le menzogne si tramutano in verità».

Il romanzo sembra anche voler fare i conti col Black Zionism (o se preferite Back-to-Africa), il movimento che auspicava un ritorno dei neri americani alla loro terra madre, il continente africano, e che si scontra col paradosso di uomini e donne che finiscono per risultare sradicati in ciascuna delle due terre. Quello che fa Gyasi è una cosa simile, in fondo: cresciuta in Alabama ritorna nel natio Ghana per piangere i propri morti e narrarne le molte storie. E, in parallelo, è il percorso che fa anche l’ultima discendente di questa lunga araldica, Marjorie, che dall’Alabama periodicamente va a trovare la nonna a Cape Coast e immancabilmente viene individuata dai locali come una straniera da turlupinare con tour farlocchi al Castello, che lei sa benissimo essere gratis. Il che mi ha ricordato – ma la memoria potrebbe giocarmi un brutto scherzo – un racconto di Adichie in cui si guardava con una certa condiscendenza a quei neri statunitensi che si imbarcavano in tour guidati verso la loro terra d’origine con la preprogrammata sosta pianto di fronte alle grotte in cui venivano stipati i loro antenati schiavi in attesa di essere trasportati nelle Americhe.
Le differenze di pigmentazione della pelle di primo acchito sembrano essere uno dei nodi del romanzo, ma mascherano una più sottile e intuitiva ricerca: quella dell’identità e della sua necessaria messa in crisi. Obroni che sta per «uomo bianco», è appena diverso da abro ni che significa «uomo malvagio» e lungo tutte le oltre trecento pagine del libro di quest’assonanza non abbiamo di che dubitare, d’altronde: «Il sorriso di un uomo bianco non promette mai nulla di buono».
A un certo punto del romanzo, c’è un ribaltamento dell’immaginario colonialista dei selvaggi cannibali: nelle dicerie popolari che si tramandano in twi sono gli uomini bianchi a cuocere a fuoco lento nei pentoloni bollenti gli uomini e le donne nere che catturano. Un dialogo, e un momento, che potrebbe essere comico se non fosse tragico. L’immagine del calderone fumigante – a dire il vero non fra le trovate più intuitive uscite dalla penna di Gyasi – verrà di nuovo adoperata per simboleggiare la Costa d’Oro ghanese e il ribollire di tensioni che già prima dell’arrivo dei bianchi aveva tutti gli ingredienti per risultare esplosivo.
L’esperienza del contatto con l’alterità genera alcuni dei passaggi meglio riusciti dell’opera; la prima volta che Esi vede un bianco non riesce a associarlo a nulla del regno naturale o animale e, di nuovo rovesciando un tropo, afferma: «Questa gente è contronatura».
Oltre due secoli e sedici generazioni dopo, portati per mano in un viaggio epico e doloroso, capiamo che la Storia non è materia inerte, ma costantemente plasmata e in necessità di riscrittura. Il romanzo di Gyasi nasce da un «ritorno» in Ghana, un viaggio che prende le mosse dal non accontentarsi della versione coloniale della «sua» storia che le era stata fornita fino a quel momento, dalla istintiva comprensione che «le cicatrici sono ereditarie e la sua gente le porta ancora addosso».
Chiuderei con le parole di un altro Kojo, Nyarko, un altro protagonista in questa incredibile concatenazione di personaggi: «Noi siamo portati a credere a coloro che in quel momento detengono il potere. Sono loro che mettono la storia nero su bianco. Ecco perché, quando studiate Storia a scuola, dovete sempre chiedervi quale racconto vi state perdendo, quale voce è stata soppressa a discapito dell’altra. Quando l’avrete capito, dovete poi scoprire anche come sono andate le cose. Solo allora comincerete a avere un quadro più chiaro della situazione, benché imperfetto».




17 Comments