«Durata della lettura: circa quattro ore. Durata del ricordo, come per l’autrice: il resto della vita» scrive l’amico e premio Nobel Iosif Brodskij riguardo a questa delicatezza letteraria che è I beati anni del castigo di Fleur Jaeggy. Questo breve romanzo è indimenticabile perché è perfetto nella forma così come nella sostanza, per la scelta delle parole più poetiche e eufoniche della lingua italiana, perché lo pensiamo come un ninnolo artigianale trovato per caso in una bottega di paese. È vitale come un sospiro di sollievo quando in mezzo a tanta violenza linguistica si trova finalmente una zona nascosta di bontà e beltà. I beati anni del castigo è difatti un unico respiro irripetibile, che ha l’aroma fresco e pungente della vegetazione montana svizzera. Lo si può venerare tenendolo come unico libro sempre con sé o come livre de chevet. E ancora – scelta radicale e da esteta – si potrebbe voler dismettere tutto per tenerlo come unico possedimento; lo scrive la Jaeggy stessa che «solo un esteta può rinunciare a tutto.»
L’autrice, un po’ svizzera un po’ italiana ma soprattutto oltre ogni confine geografico e ideologico, ha scritto un grande ossimoro, che poi altro non è che la vita. A partire dal titolo, dove gli anni del castigo sono definiti come i più belli e beati. L’educazione in un rigido collegio svizzero – l’unico vero elemento autobiografico – è la prigione in cui le giovani ragazze del romanzo trascorrono infanzia e adolescenza. Il collegio è un idillio per molte di loro, che si sentono protette dalla rigida disciplina e nella repressione delle emozioni, costrette però a crearsi una doppia vita dove ognuna è maschera di se stessa e dunque senza personalità, annullata nell’ossessiva ripetizione della quotidianità. Nella narrazione queste, tranne alcune eccezioni, non hanno neppure nome, sono nessuno agli occhi della protagonista. A loro si oppone – ancora un ossimoro – l’io narrante, studentessa del collegio anche lei, che desidera però la solitudine, passeggiare all’alba, cercare di guardare oltre, di trovare l’assoluto, anelando a entrare nella vita per non percepirla più solo di riflesso.
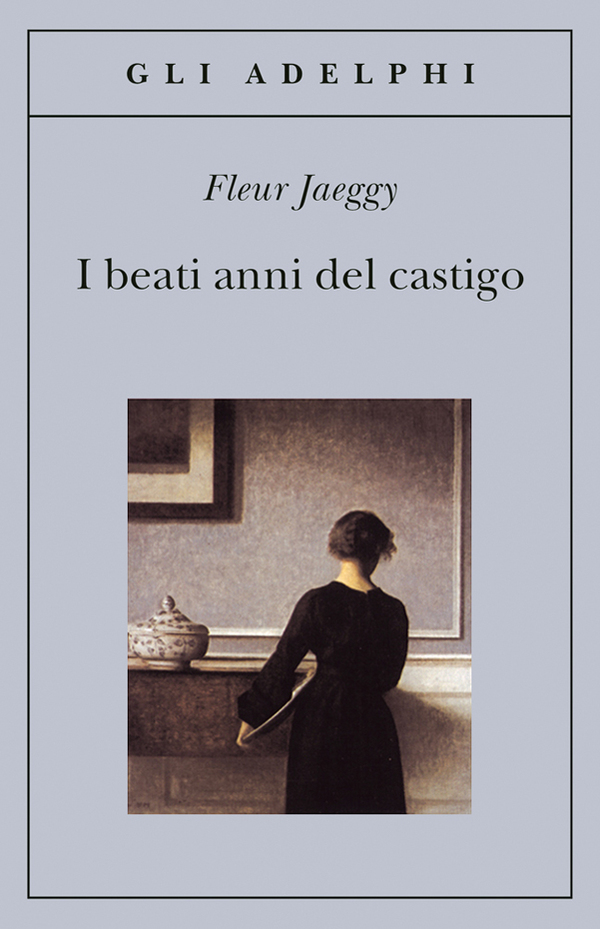
«Suona la campanella, ci alziamo. Suona ancora la campanella, dormiamo. Ci ritiriamo nelle nostre stanze, la vita l’abbiamo vista passare dalle finestre, dai libri, dall’alternarsi delle stagioni, dalle passeggiate. Sempre di riflesso, un riflesso che sembra raggelato sui davanzali.»
E visto che chi cerca la stessa cosa, chi desidera la vita nelle sue contraddizioni si incontra riconoscendosi, è lei e non le altre che si avvicina a Frédérique, la nuova arrivata, impassibile e perturbante. Scrive la Jaeggy che nasce tra le due un’amitié amoreuse e difficilmente si potrebbe definire in altre parole un rapporto tanto complesso e altrettanto puro. La ragazza è affascinata dalla presenza assente di Frédérique, dalla sua sostanza inavvicinabile perché lei non sembra affatto di questo mondo, di questa realtà. Se ne innamora ma ha paura di confessarlo perfino a se stessa, per pudore, per via dell’ottusa educazione del collegio. Odia amarla e tuttavia non ne può fare a meno. La carnalità e la passione sono totalmente represse nei gesti e nelle parole; loro non si parlano e non si toccano eppure si sprigiona una violenza potentissima che sfiora la morte negli occhi frigidi di Frédérique. È la migliore, la più disciplinata, la perfezione che viene richiesta in collegio, Frédérique disobbedisce dando al mondo ciò che questo vuole ma non essendo presente qui con né il corpo né con la mente.
«Il suo modo di apparire colpiva. Era senza emozione, senza vanità, senza modestia, come se seguisse le sue spoglie. Impassibile, ma negli occhi e nella bocca qualcosa aleggiò di fuggitivo. Una violenza dell’anima per una volta trasfigurò il suo viso, pur immobile. Frédérique tornò al suo posto. Considerai che fosse ancora di più ciò che pensavo. C’è qualcosa di assoluto e imprendibile in certi esseri, sembra una lontananza dal mondo, dai vivi, ma sembra anche il segno di chi subisce un potere che non conosciamo.»
Per punizione e per contrasto la protagonista si avvicina a Micheline, un’amica normale, di quelle di cui si parla al passato quando ci si ricorda di loro.
«Era una creatura esteriore, e questa fu la prima peculiarità che mi attirò. E l’allegria. Mi mostrò subito i suoi vestiti. Negli armadi sembrava ci fosse il sole. Quando mi abbracciava, e io lasciavo fare, sentivo il suo corpo forte e sano su di me. Come di una nutrice. Tutto era morbido e giovane, atletico. Mi abbracciava come avrebbe abbracciato la folla. Senza peccato, senza vizio. Direi quasi da vera compagna, anche se il termine si è snaturato. Era una carnale. Non come Frédérique e io, che non osavamo neppure toccarci, né darci un bacio.»
A Frédérique la unisce invece l’assoluto, qualcosa che forse nella vita capita una volta sola. Piace pensare, se pure lasciato cadere ancora nella fantasia letteraria, che Frédérique stia alla protagonista come Ingeborg Bachmann a Fleur Jaeggy. Il loro rapporto è stato assoluto e impenetrabile, spezzato troppo presto dalla morte della Bachmann. Scrive di lei la Jaeggy:
«Era una donna bellissima, generosa, intelligente. Con lei ho conosciuto la vera amicizia, quella che illumina la vita. Profonda, complice, senza inganni. Non mi sono ancora abituata alla sua assenza.» (Elle, febbraio 1990)
Frédérique si allontana dal collegio, alla stazione si salutano in modo freddo, si lasciano una lettera scostante e una dichiarazione d’amore tardiva e fugace, ma tuttavia non può esserci un addio. Anni dopo si ritrovano a Parigi e Frédérique vive ormai in un sepolcro, da eremita, da asceta che ha rinunciato a sé, come una santa colta nel momento di massima estasi mistica. Il suo stato, ci fa capire la Jaeggy, trova posto nel mondo solo in manicomio, un altro carcere, un altro castigo che non può però confinarla. Fin dall’incipit, trai più belli della letteratura, la Jaeggy ci avvolge con la suggestione del manicomio, quello di Herisau, dove Robert Walser ha vissuto e, passeggiando, si è lasciato morire nella neve.
«A quattordici anni ero educanda in un collegio dell’Appenzell. Luoghi dove Robert Walser aveva fatto molte passeggiate quando stava in manicomio, a Herisau, non lontano dal nostro istituto. È morto nella neve. Fotografie mostrano le sue orme e la positura del corpo nella neve. Noi no conoscevamo lo scrittore. E non lo conosceva neppure la nostra insegnante di letteratura. A volte penso sia bello morire così, dopo una passeggiata, lasciarsi cadere in un sepolcro naturale, nella neve dell’Appenzell, dopo quasi trent’anni di manicomio, a Herisau.»
Chi vive si avvicina alla morte, supremo ossimoro di I beati anni del castigo, mentre gli altri si preservano credendo di non invecchiare, avvizzire. La morte è la dea ex machina del romanzo, tutto svanisce e solo Frédérique lo ha capito. Muoiono i direttori del collegio, i genitori delle ragazze, l’edificio stesso non esiste più perché nessuno se ne ricorda ed è stato sostituito da una clinica per ciechi. Ciechi sono tutti coloro che non riconoscono la vita come un’unica grande prigione, credendo di poter sfuggire alla morte.




20 Comments