Ora, era ricominciata la sua lotta, la lotta giornaliera con la natura e con l’ingiustizia dei suoi simili. Nel crepuscolo di quella valle lontana, la sua figura incombe, ma la sua identità svanisce.
Hamlin Garland raggiunge la notorietà letteraria con la raccolta esordiente Racconti dal Mississippi (Six Mississippi Valley Stories, 1891), che ottiene subito un notevole successo. Nato a West Salem, Wisconsin, nel 1860, segue la famiglia in Iowa e in seguito in Sud Dakota, prima di vendere il suo lotto di terra e trasferirsi a Boston, concentrandosi da autodidatta sulla sua educazione. Qui, venendo incontatto con circoli letterari e artisti, pubblica racconti, componimenti poetici e articoli d’inchiesta, nello specifico sulla riforma agraria, tutti con un filtro condiviso: quel realismo che caratterizza tutta la sua prima fase letteraria.
La sua fama viene riconosciuta dai sui stessi contemporanei, ma nonostante ciò la notorietà di Hamlin Garland diminuisce poco a poco dopo la sua morte, a Hollywood, nel 1940, rimanendo legata principalmente alla sua opera di maggior successo, il romanzo Rose of Dutcher’s Coolly, apparso nel 1895, e il suo sequel, A Daughter of the Middle Border, nel 1921, che gli valse il Premio Pulitzer nel 1922.
I Racconti dal Mississippi (editi in Italia per la prima volta da Neri Pozza nel 1965 e pubblicati nel 2017 da D Editore nella collana a cura di Valerio Valentini) sono storie di denuncia portate avanti con caparbietà e senza mezzi termini. Il nodo centrale che Garland vuole stringere lungo tutti i sei racconti della raccolta, è detto sin da subito, nella dedica ai genitori. Lo scrittore definisce la loro vita un «pellegrinaggio di mezzo secolo sulla strada maestra della vita che ha portato loro solo fatiche e miseria»: e non solo. Chiama quello dei genitori un «silenzioso eroismo», evocando la lotta quotidiana dei contadini contro la massacrante vita rurale.
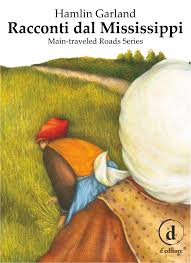
Garland dedica la sua penna a un’America che si avvia a essere una potenza economica mondiale, diventando uno dei massimi rappresentanti del regionalismo e di quel local color che si propone di esprimere il vernacolare, il folclore e la crudezza della terra. Attraverso il realismo si emancipa del tutto dagli influssi letterari del vecchio continente, dall’ideale romantico europeo del Midwest americano, quello degli indiani e dei pistoleri. I pellerossa e gli eroi erranti a cavallo, onnipresenti nell’immaginario comune delle terre colonizzate non trovano spazio nei Racconti del Mississippi. Dunque cosa rimane a Garland? Le splendide descrizioni paesaggistiche popolate da uomini e donne distrutti dall’ingiustizia di una vita crudele e senza speranza.
Già nella premessa al libro l’autore illustra la sua prospettiva: dopo anni di assenza dalle terre natìe, il ritorno alle origini è decisivo. Le fattorie gli appaiono deprimenti, le città misere, gli uomini e i suoi stessi genitori disperati e intrappolati. In Una storia dal Wisconsin, il racconto che apre la raccolta, l’autore infonde molto del suo vissuto nel protagonista descrivendo il ricongiungimento familiare che, invece di essere un passaggio rinfrancante, si trasforma rapidamente in una spirale di tristezza, fastidio e sgomento: «Howard non poté mangiare molto. Era preoccupato per lo strano silenzio e l’oppressione di sua madre, nauseato dalle lunghe e profonde sorsate con cui il vecchio mangiava il suo pane e latte, e dal modo in cui mangiava il ragazzo: teneva il coltello impugnato stretto nel palmo della mano, nocche in fuori, e spalmava il miele sul pane».
L’atmosfera avvilente nella quale Howard, un attore che ha avuto successo dopo esser scappato da quelle terre senza pietà, viene riportato in modo brusco una volta tornato, gli si avvinghia intorno al collo e non gli dà possibilità di scampo. Questi uomini non hanno scelto il loro destino, insiste Garland, e sono condannati a vivere senza possibilità di riscatto, giudicati per la propria piccolezza da quella che lui chiama la maledetta aristocrazia europea. A questo proposito, in Tra i filari di granoturco, un personaggio si lancia in un’infervorata invettiva contro questa classe: «Noi che si lavorava laggiù si diventava sempre più braccianti e meno esseri umani. Sai, Waupac è una specie di luogo di villeggiatura e la gente che veniva d’estate, quando ci incontrava nei campi o nelle botteghe, guardava noi contadini dall’alto in basso. Non li potevo sopportare. Per Dio! – disse con un improvviso accesso di rabbia del tutto insolito. – Preferirei vivere su un iceberg e campare di granchi, piuttosto che sentirmi chiamare “campagnolo” da qualcuno che mi passa avanti per strada».
Lo scrittore non solo si fa portavoce delle condizioni di vita dei contadini, ma ammanta le storie di tutta l’amarezza di cui dispone davanti all’immobilità sociale di questa classe. Perché vuole scuotere e sconvolgere i lettori. La premessa, datata 1 marzo 1891, ne è un manifesto: «Il lettore non deve dimenticare i tempi in cui furono scritti. Che presentassero un’immagine fedele delle fattorie di quel tempo nessuno meglio di me lo può sapere, perché io ero là, e facevo il contadino». Alcuni personaggi sono rassegnati a trascorrere la vita intera sulle zolle di terra che lavorano, altri tentano di staccarsi da quelle lande e di trovar fortuna cercando il successo mitizzato dei colonizzatori, per poi fallire. Gli eroi dell’autore statunitense vengono descritti senza dolcezza o esclusione di colpi. Giovani uomini con le spalle così piegate dal lavoro da sembrare vecchi, gli occhi sbiaditi, malnutriti i corpi, le mani scarne dalle giunture gonfie, la fatica nell’esprimersi. Garland non regala alcuna finta dignità a questi uomini: si stacca completamente dal topos del contadino immerso in un quadro rupestre, curante solo della Natura e dei suoi voleri. Sono uomini miserevoli e miserevoli li restituisce alla carta.
Il riscatto desiderato di volta in volta dai protagonisti dei racconti non si avvera mai, oppure è minimo, ridicolo e fastidiosamente superfluo. Un esempio è Il viaggio della signora Ripley, il quinto racconto: questa donna non torna a casa da quando si è sposata e trasferita nella fattoria del marito, lavorando tutti i giorni e non vedendo i genitori da anni. Ha un unico desiderio: quello di far loro visita. Non solo lo esprime, lo pretende. Sono poveri, il marito gli fa notare, e non possono permettersi il biglietto del viaggio. Tuttavia la donna è caparbia, trova il denaro da sola, va oltre tutti i minimi eppure così insormontabili problemi che sembrerebbero esserci davanti all’idea di un viaggio. Ma Garland rimane fedele al suo leitmotiv: non dà al lettore la soddisfazione dell’agognato incontro tra la donna e i suoi genitori, neanche un solo particolare. Al contrario, lo scrittore illustra la ripresa della donna dei suoi ruoli quotidiani e la sua nitida consapevolezza che il suo unico desiderio è ormai compiuto. Garland lo racconta con una lucidità chirurgica, descrivendo gli avvenimenti così come gli si presentano davanti agli occhi, con il dolore e la delusione che li accompagna secondo quella cronaca lineare che lui stesso chiamerà veritista.
Frustrazione e rabbia, mitigate di volta in volta dalle precise descrizioni naturali, splendide, che lo scrittore dipinge per il lettore con lo sguardo accorato di un amante. Svestendo i panni del realismo, il suo sguardo rivolto alla Natura si addolcisce ogni volta e il suo occhio diventa più accorto ed ecco le innumerevoli sfumature nel descrivere il verde delle colline, il modo di incresparsi del Mississippi lungo gli argini, l’aria fredda e immobile all’alba, il caldo statico delle prime ore del pomeriggio.
Ed è proprio la sensibilità di queste descrizioni e la disperata rassegnazione di quelle dei contadini che danno vita al vero conflitto in tutti i sei racconti. L’autore che riesca a illustrare le praterie e il lavoro costellato di isolamento e delusione che ne deriva e ad accostare a questo dark side la bellezza naturale della campagna alla ricerca di un equilibrio perfetto tra i due elementi. Il lettore è catapultato da una realtà all’altra, senza poter respirare, su un’altalena che gli restituisce finalmente un’America vera: «…lassù, sotto l’inesorabile vastità del cielo, un profondo disgusto della vita stessa si impadronì di lui. Pensava all’infinita tragedia di queste vite che il mondo ama chiamare pacifiche e arcadiche. La sua mente si spinse a ricercare un modo di portare loro aiuto. Cosa poteva fare lui per rendere quella vita un po’ più degna di essere vissuta? Nulla. Essi, in fondo, dovevano vivere e morire…».




17 Comments