«Quando avremmo potuto riappropriarci delle nostre memorie?»
«L’ultima bottega era il punto d’incontro degli appassionati di pernici, uccelli comuni nelle nostre montagne, un simbolo per il nostro popolo. Sapevo che la pernice può diventare nemica a se stessa, perché i cacciatori la usano come richiamo per attirare le sue consimili. Non capivo perché mia madre ci paragonasse, noi curdi, alle pernici, ma ero ancora un ragazzino.»
«Qui, la Voce del Kurdistan… – era la radio pirata della resistenza. E io ascoltai di nuovo l’inno nazionale Ey Raquib – Amici, il popolo curdo è vivo e nulla potrà ammainare la sua bandiera.»
«Noi curdi non saremo mai niente. Siamo maledetti, è il nostro destino. Pensate alla nostra storia, siamo il popolo più antico della regione, eppure i turchi arrivati dopo di noi hanno uno stato, e noi sempre niente […] ma il fatto più strano è che, nonostante i massacri, noi esistiamo ancora. I Caldei, i Babilonesi, i Sumeri hanno costruito degli imperi, di cui non resta nulla. Noi esistiamo ancora, parliamo la nostra lingua, eppure non diventiamo niente. Rifiutiamo di sottometterci, ci ribelliamo e continuiamo a non essere niente…»
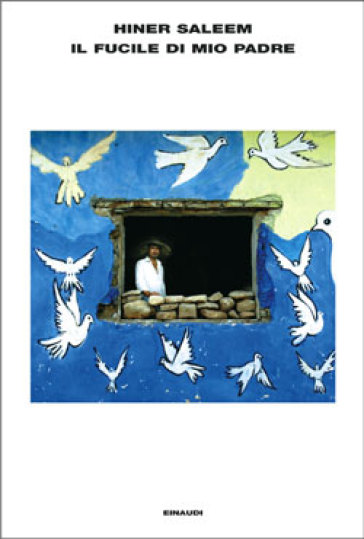
«D’un tratto, mi ricordai del vecchio Brno di mio padre. Cosa avevamo ottenuto con tutti quegli anni di lotta? Ci voleva altro. Ma cosa? Io non conoscevo la risposta. Guardai il mio kalasnikov, sempre più convinto che non si poteva scavare una galleria con un semplice ago. Mi commossi pensando al nostro destino.»
«Il mio nome è Azad Shero Selim. Sono il nipote di Selim Malay. Mio nonno aveva uno spiccato senso dell’umorismo. Diceva di essere nato curdo, in una terra libera». Incomincia così Il fucile di mio padre (Le fusil de mon père, 2014) di Hiner Saleem, un regista curdo (anche Azad da grande vuole fare il regista) che si è cimentato con la stesura di un libro di memorie però trasfigurate, romanzesche. La primissima frase è una perentoria testimonianza, sempre finzionale, della soggettività del giovane protagonista di questa storia.
L’amaro umorismo dell’incipit scaturisce dall’ambiguità del concetto di libertà, soprattutto per un popolo, quello curdo, più volte soggiogato dai soprusi di altri popoli.
«Ma io, Azad, ero ancora un bambino.» È dalla prospettiva di un innocente che comincia il racconto di un uomo che retrospettivamente interpreta, attraverso il ricordo, la difficile vita dei suoi compatrioti. Suo padre è il telegrafista ufficiale del generale Moustafa Barzani, a capo dei miliziani curdi, per cui intercettava e decifrava in alfabeto morse i messaggi degli iracheni. Quando Azad era ancora un bambino, già la sua famiglia veniva decimata dalla guerriglia: «mia madre non sorrideva più; piangeva suo fratello e gli altri sei parenti uccisi. Ma io, ero ancora un bambino».
Quando i golpisti Ahmad Hassan Al-Balr e Saddam Hussein Takriti prendono il potere, con la nascita del partito Baas della Resurrezione Araba Socialista, ai peshmerga curdi non resta che resistere e morire sulle loro montagne, perché gli iracheni parlavano di una pace che si sarebbe scoperta apparente e strategica.
Azad crede all’illusione di una libertà a cui si arriva con il sangue: «È toccato a Saddam di venire sulle montagne. Ha accettato tutto, salvo l’indipendenza del Kurdistan. Curdi e arabi, noi avremmo condiviso tutto, come fratelli! A partire d’allora, tutti sorridevano. Eravamo tutti eccitati dall’euforia della pace. Io ci credevo…».
La casa natale ad Aqrah (dove nacque anche l’autore del libro) è stata rasa al suolo dai bombardamenti quando la famiglia del protagonista si era dovuta allontanare. Per Azad questo sacrificio aveva portato a una libertà che tuttavia si sarebbe rivelata illusoria. A scuola anziché curdo si incomincia a parlare arabo e quindi alla fine dell’anno Azad viene bocciato. Oltre che a scuola, anche in televisione non esistono programmi in curdo; infatti, Azad si appassiona a un teleromanzo egiziano e vede film indiani senza capirli. La sua curiosità fa si che legga poesie (i poemi di Malaye Djeziri) e dipinga, imparando al contempo come si usa un fucile.
«Mahmad Shekho continuava a ripetere che noi non potevamo liberare il nostro paese solo con le armi, che ci servivano anche violini e tamburi. Abbiamo registrato molte canzoni per la nostra radio, la Voce del Kurdistan.» Esiste quindi una resistenza anche linguistica e culturale. Sami, un pittore che dipingeva giovani curde, siccome non aveva paura di continuare a manifestare la sua aperta opposizione al regime di Saddam, scomparve per sempre e divenne un martire.
Il padre e il fratello del giovane protagonista partono sempre per una guerra che scandisce ogni momento dell’esistenza. «I bombardamenti sono diventati quotidiani. Il nostro orario totalmente sconvolto: la scuola cominciava ormai quando si era fatto buio. Ci stringevamo intorno alla lampada a petrolio per seguire le lezioni; faceva molto freddo».
Alla causa curda viene conferità una sacralità tale da renderla perfino più importante della propria famiglia: «Chi è morto? – Nessuno – Allora cos’è questa bara? – È vuota – Perché le donne piangono? – Andiamo a uccidere nostro cugino Mushir». Una volta giustiziato il cugino, si scoprì che non era un collaborazionista. Aveva semplicemente un’amante a Mossul.
Hiner Saleem, accanto alla narrazione vera e propria, ci presenta gli eventi della storia e le alleanze internazionali. Non tutti però morivano in guerra. Gli americani chiamavano eroi i peshmerga senza aiutarli sul campo. Sembra che tutti abbandonino i curdi: «Una solitudine mortale si era impadronita del nostro popolo. Eravamo traditi dagli americani, come già era successo con i sovietici; e in una bella giornata di marzo Saddam Hussein l’iracheno firmò un accordo [Algeri, 6 marzo 1975] con lo Scià d’Iran: perdevamo ilnostro ultimo appoggio».
Da bambino innocente a piccolo militante, come fosse un romanzo di formazione, Azad si allontana dalla famiglia più volte per peregrinare tra le montagne curde (al di là delle quali «i curdi non avevano amici», e difendere il suo popolo.
Dopo il doloroso fallimento della resistenza curda, Azad e la sua famiglia diventano degli aïdoun, cittadini di secondo ordine, letteralmente «colui che rientra nei ranghi». La loro vita è quasi impossibili e le privazioni sono onnipresenti: «Il nostro essere aïdoun ci vietava l’ingresso a molti impeghi nelle università, nell’amministrazione, in tutti i posti delicati. In realtà, quella regola era valida per tutti i curdi. Bastava pronunciare una sola parola non gradita al governo, e la persona che l’aveva pronunciata spariva. Le moschee erano chiamate moschee del Baas, così come le strade, i quartieri, le colline; tutto apparteneva al Baas, anche i bordelli. Tutti seguivano il proverbio: Tieni il tuo cappello, per evitare che il vento te lo porti via».
Anche il cammino scolastico di Azad è compromesso: «Dal momento che il mio certificato scolastico non era stato riconosciuto valido per il periodo che avevo passato in montagna e in Iran, mi ritrovai nella stessa scuola, nella stessa classe, nello stesso banco. Avevo quattro anni di ritardo. Dovetti ricominciare i miei studi in arabo. Alla fine dell’anno fui promosso e ammesso alla scuola media». Con uno stratagemma all’anagrafe, il padre di Azad riuscirà a falsificare, fingendo la morte prematura di un figlio omonimo, il suo certificato di nascita, così da ringiovanirlo di quattro anni (anche l’autore è del 1964).
Il protagonista incomincia a conoscere clandesinamente la letteratura europea (Bernard Shaw, Jack London, Gorki, Sartre e altri) e continua a militare tra le fila della resistenza, con la polizia segreta che controlla sospettosamente la sua esistenza.
In questa storia tutto è politico. Nelle biblioteche, i libri non irregimentati sono soggetti a un’atroce damnatio memoriae: «Tutti i bibliotecari avevano ricevuto una lista di libri, che dovevano essere spediti a Baghdad per essere distrutti. Erano dei vecchi libri, il cui solo difetto era di non seguire la linea del Baas. Il bibliotecario della nostra città, che si fidava di me, mi aveva affidato dei libri curdi e, per me, rappresentava un dovere patriottico il fatto di nasconderli, e di conseguenza salvarli».
Kamal, un amico del fratello di Azad, curdo convertito al partito Baas, graziandolo in memoria di un passato comune, gli confida che a breve sarebbe stato prelevato e poi ucciso. Azad quindi ottiene faticosamente un passaporto e percorre la via dell’esilio.
«E io, Azad, non ero più un ragazzino.» «In camera mia, preparai un piccolo sacco da viaggio. Ci misi dentro un costume curdo, una cassetta di musica curda, un libro di poesia curda e scesi le scale. Sei pronto? – chiesero insieme i miei genitori. Sentii il mio cuore battere fino a spezzarsi e gli occhi riempirsi di lacrime. Temevo di vederli per l’ultima volta. Non sapevo cosa sarebbe successo.»
«Azad è vissuto per anni in Italia, senza riuscire a ottenere il permesso di soggiorno», ci viene spiegato alla fine del libro, «perché l’Italia non riconosce ai curdi lo statuto di rifugiati. Si è stabilito in Francia.»




Given how popular run-three games are at the moment, you should still study more about them even though I’m sure you’ll need the knowledge from the previous post.
Avevo quattro anni di ritardo.