«Dall’altra parte, sulla costa africana, migranti marocchini e subsahariani attendono la loro occasione per compiere la traversata. Nelle giornate di cielo sereno l’Europa si vede chiaramente, edifici bianchi si stagliano netti sulla costa rocciosa. Così vicina, praticamente a un passo… Arrivano su pescherecci malandati e perfino su camere d’aria di ruote d’autocarro; dall’inizio del nuovo millennio ne sono annegati a migliaia nello Stretto. A Ksar es Seghir [cittadina costiera della regione di Jebal, nel Marocco nord-occidentale] un pescatore spazia con lo sguardo sulle onde alte e sospira: “Qui è più facile trovare nella rete il cadavere di un uomo che un pesce”.»
«Guardate, sta facendo una prova…» spiegò Saleh soddisfatto. Murat sollevò la testa e disse qualcosa che fece ridere sua madre. «Che cos’ha detto?» domandò Thouraya. «Che sta bene come nel suo grembo», rispose Saleh.
È uscito lo scorso ottobre, per Iperborea, tradotto da Elisabetta Svaluto Moreolo, un romanzo brevissimo e meraviglioso: La morte di Murat Idrissi (De dood van Murat Idrissi , 2017) di Tommy Wieringa. Anche in un altro libro, Dit zijn de namen (Questi sono i nomi, Iperborea, 2014), intitolato come l’incipit dell’Esodo, il narratore olandese ha trasfigurato narrativamente i profughi di tutti i tempi, soprattutto dei nostri (i personaggi, verso la fine del romanzo, andranno pure su YouTube).
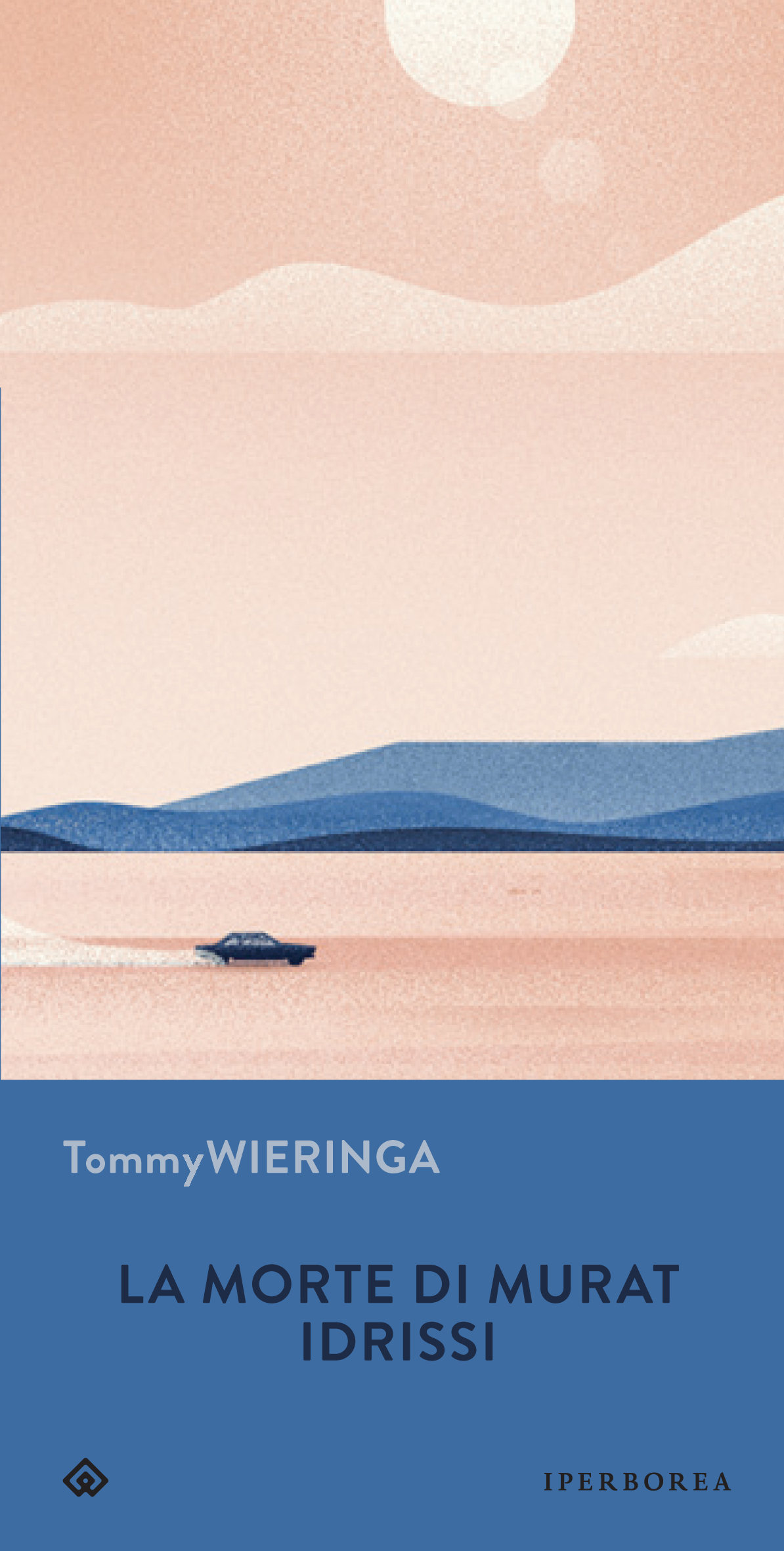
La storia è tragicamente semplice: il diciannovenne marocchino Murat Idrissi, giovane clandestino che insegue il sogno europeo, muore compresso e asfissiato in un bagagliaio. Ilham e Thouraya, ragazze di origini marocchine, olandesi di seconda generazione, una volta sbarcate sul suolo spagnolo dopo una piccola vacanza a Rabat, viaggiano insieme al suo cadavere accartocciato, decomposto, stipato, il cui odore appesta le infastidite viaggiatrici, angosciate dalla necessità di doversene disfare, quasi come se fossero le protagoniste di un orrendo romanzo picaresco.
L’incipit è geologico, ancestrale e poco oltre Wieringa anticipa ciò che purtroppo tutti sappiamo:
«Benché la frattura tra la placca euroasiatica e quella africana non sia che un graffio sulla crosta terrestre, separa risolutamente le parti del mondo. Qui è qui e là è là.»
Abbiamo interiorizzato tutte le differenze (religiose, culturali, sessuali), permettendoci l’illegittimo dono di reputarci umani, riempiendoci la bocca di parole consolatorie e ipocrite. Anche se le loro famiglie sono marocchine e sono state dimenticate non importa se da Dio o Allah, Ilham e Thouraya, per quanto forse ci provino, non sanno rispettare l’alterità.
«Seguirono Saleh tra le case, nel dedalo di viuzze. Thouraya, con gli occhiali da sole di Miu Miu sul naso e la borse color salmone di D&G appesa alla spalla, sembrava una star del cinema in missione di beneficienza» (p.34). Le giovani olandesi non si sentono a casa loro:«Ilham si vergogna per loro [alcune famiglie marocchine], per il loro aspetto disordinato, per la loro africanità – sembrano così fuori luogo sul continente dove hanno appena messo piede.»
Forse aiutano Murat più per denaro e compassione che per autentica solidarietà: non perché sia giusto, e assurdo che il mondo sia così. D’altronde, l’anziana madre aveva minacciato di suicidarsi qualora non avessero aiutato il figlio.
Finito un piccolo compendio di storia delle navigazioni, il narratore entra in media res: le ragazze olandesi, con l’autoctono Saleh nelle vesti di mediatore, vanno a conoscere la famiglia di Murat e opponendo pochissime resistenze si lasciano convincere a trasportarlo illegalmente in Europa. Murat non è un santo per nessuna religione: attraverso un forte effetto di realtà, viene presentato come colui che, così si vocifera, ha sfruttato una ragazza con un ritardo mentale. Questo espediente fa sì che l’empatia stenti ad attecchire nella mente del lettore. Poi però il narratore non ritorna sul discorso, e nei confronti di chi sappiamo sarà un cadavere torna un senso di impotente e in un certo senso colpevole pietà.
Una delle ragioni per cui vale di più la pena leggere questo romanzo è lo stile quasi espressionistico, sinestetico di Tommy Wieringa: frasi che sembrano sussulti, nominali ma non giornalistiche, frante, tombali. Ecco un esempio, dove viene descritto il panorama imputridito delle baraccopoli che come metastasi proliferano nell’hinterland marocchino. Al lettore (e anche a me, confortato da un benessere che non ci meritiamo) sembrerà di stare lì:
«Tutto si moltiplicava in modo esponenziale sotto quel sole furibondo. Mosche, cani persone; i batteri nella carne appesa fuori nei vicoli […] il marciume, gli storpi, le loro ferite, la sporcizia. Quella era dovunque, era lo stato naturale di ogni cosa.»
Murat, una «creatura che non è potuta nascere», non è un martire perché non c’è redenzione, né giorno del giudizio. Il suo cadavere marcirà sul ciglio della strada, senza preghiere. Il nostro senso di colpa non basta: bisogna reagire.




18 Comments