«Come se ogni quadro fosse un “Infinito minimo” che Pericoli ha rinchiuso in un rettangolo, perché sa che con l’Infinito bisogna andarci piano. Dell’Infinito si deve prendere q.b., come si dice nelle ricette mediche per i farmaci più forti: una dose eccessiva può intossicarci, alterarci, renderci infermi.
Ho l’impressione che Pericoli con questi quadri abbia mitridatizzato l’Infinito».
Antonio Tabucchi, Il Cielo sopra, in Tullio Pericoli. Sedendo e Mirando. I paesaggi 1966-2009, catalogo della mostra (Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini”, Ascoli Piceno), Skira, Milano 2009.
Ho incrociato Tullio Pericoli incontrandone i disegni, per la prima volta, dentro uno splendido libro di Antonio Tabucchi: Racconti con figure (Sellerio, 2011) [di cui ho scritto qui] e da allora le sue opere hanno affiancato il mio percorso con un candore umile e delicato, tipico di quest’uomo senza volto che s’identifica e s’incarna nelle sue mani sensibili.
Mi sono dapprima innamorato dei suoi ritratti, come la maggior parte di noi. E mi ha sorpreso la sensazione di «riconoscerne», alcuni, come se fossero parte del mio immaginario. Li avevo già visti nei giornali? Probabile. Eppure, ho avuto sempre la sensazione che questo riconoscimento fosse frutto del fatto di conoscere le biografie dei personaggi ritratti, di aver letto le loro parole o visto i loro film, come se la loro vita risuonasse, in modo del tutto sentimentale, nei suoi disegni. Come se li riconoscessi, per sensibilità, non attraverso la memoria. Mi vengono in mente i suoi Calvino o Beckett o Kafka o Stevenson, oppure Leopardi. Sento che questo misterioso riconoscimento, piuttosto che venire dalla facile soluzione di averli già visti da qualche parte, venga più che altro dall’identificare, in quei ritratti, la trasfigurazione delle loro figure, filtrate attraverso ciò che scrissero e che fecero. Come se tra le linee di quei volti vi si potesse distinguerne l’opera, in qualche modo. Il loro significato essenziale, il loro «infinito minimo».
In seguito rimasi affascinato da un grande manifesto nel quale era riprodotto un suo Frammento di frammenti o un Senza titolo (non ricordo esattamente), una delle opere che fa parte dell’ultima fase della sua pittura paesaggistica. Mi si aprì un mondo, un universo nuovo e inaspettato.
Scoprii che da quasi cinquant’anni Pericoli ritraeva il paesaggio marchigiano attorno ad Ascoli Piceno, sua patria natale. Senza mai (o quasi, questo lo scoprii in seguito) ritrarre alcuna figura umana o pseudo-tale. La cosa mi sorprese e mi entusiasmò. Come poteva, il maggiore ritrattista italiano vivente (tra i più importanti del mondo intero), procedere in quella direzione così apparentemente antitetica e in modo così marcatamente diverso?
«Due poli risaltano nella pittura di Tullio Pericoli, il paesaggio e il ritratto, e fra essi corre una tensione perpetuamente irrisolta, un’elettricità di senso e di emozioni. Come dovessero illuminarsi a vicenda e si inseguissero nella stessa foresta di segni, di linee disegnative e accuratamente pensare. Senza raggiungersi mai».
Salvatore Settis, «La lingua madre di Tullio Pericoli» in Forme del paesaggio 1970-2018 (Quodlibet, 2019)
Dovetti percorrere molte strade, vie di montagna, terrose e anguste, e recarmi personalmente ad Ascoli Piceno (anche per controllare se esistesse davvero, visto il dubbio che mi aveva instillato Manganelli). Dovetti scavare nei suoi libri e nei libri che gli altri hanno dedicato a questo anomalo personaggio del mondo culturale italiano. Esplorare i suoi boschi e guardare i suoi cieli, e avvicinarmi quanto più possibile ai suoi segni, fino a toccarli. Quei solchi nella pittura che somigliano a lettere, sono grafia, sono linguaggio vero e proprio. Dovetti perdermi in quella piccola città centritaliana, per riuscire a darmi una risposta che mi potesse soddisfare, anche se parziale, anche se del tutto personale e arbitraria (a prescindere dalle testimonianze che ho raccolto in suo favore). Dovetti stare da solo, sedendo e mirando il suo Infinito, per comprenderne il viaggio, il naufragio e il ritorno in patria.
Questo è il racconto del mio, di naufragio.
Paesaggi, ovvero l’interpretazione del mondo
«Ritratti e paesaggi sono, in certo senso, agli antipodi, non tanto per l’assenza o la presenza della figura umana, quanto perché il ritratto ha come punto di riferimento inevitabile la realtà, la realtà di un volto o di un’espressione, mentre il paesaggio dalla realtà può allontanarsi, sino a limitarsi a semplici equivalenti geometrici».
Cesare Segre, «Sedendo e mirando». L’orizzonte verticale, «Corriere della Sera», 9 aprile 2009
Fino a qualche mese fa dicevo sempre, consigliandolo: «Tullio Pericoli fa questi ritratti meravigliosi, guarda (e facevo vedere all’interlocutore alcuni dei suoi ritratti più famosi). Sicuramente ne riconosci qualcuno perché sono su tutti i giornali più importanti». Poi aggiungevo, come a volervi dare un valore più alto, o comunque straordinario, quasi esoterico, di assoluta preziosità: «però fa anche questi paesaggi. Così astratti, minimi, evocativi».
Adesso devo sempre ricordarmi di non presentarlo così. Assolutamente, mai.
Si tratta, per come la penso io, di una distinzione – in questo caso specifico – grossolana e superficiale. Limitante. Il percorso di Pericoli, la sua rotta, è stata da lui percorsa grazie alle manovre spericolate di un ottimo timoniere, lo sguardo aquilino di una giovane vedetta molto attenta e capace ma, anche e soprattutto, grazie alla visione del capitano che ha saputo tracciare le linee cartografiche del mare immenso su cui la nave-Pericoli s’inoltra ancora; tutto ciò anche grazie alla grande esperienza del suo Secondo che lo ha consigliato sempre bene.
Dentro Pericoli, visibile nella sua opera, c’è un equipaggio che lavora insieme per una realizzazione più grande.
Bisogna aver visto i suoi alberi in Attraverso l’albero (Adelphi, 2012) per comprendere i suoi paesaggi, scoprire quali sono le sue fonti, tracciare la linea che va dal porto da cui è salpato a quello in cui, momentaneamente, è approdato. Dobbiamo aver visto La casa ideale di Robert Louis Stevenson (Adelphi, 2004) per capire il Robinson Crusoe di Daniel Defoe (Adelphi, 2007) e viceversa. Non perché non arrivino immediatamente, gli uni e gli altri, paesaggi e ritratti, dritti dritti ai nostri «sconosciuti fondali», alla nostra sensibilità; ma perché ogni sua opera illumina l’altra di significato e, straordinariamente, come pochissimi artisti fuori dal comune che hanno messo piede sul nostro pianeta, il tutto si completa attraverso le sue stesse (auto)riflessioni. Sempre arricchenti, luminose.
«Calvino sostiene che è impossibile, usando le parole, fermarsi alla descrizione, perché l’interiorità degli uomini, dei volti, ma anche degli oggetti, è così prepotente da sfondare il velo della forma e imporsi al di là della volontà dello scrittore, delle possibilità del suo linguaggio e delle sue parole.
Il racconto contenuto negli oggetti o nelle figure si impone a tal punto da costringere la parola a non limitarsi alla pura descrizione, ma ad andare oltre e raccontare l’interiorità, sia delle persone che delle cose. La pittura ha un’altra lingua, ha un altro modo di esprimersi, ma il problema è lo stesso. […] Nella scrittura si usano le parole per parlare alle parole di un altro. Nella pittura invece ci si rivolge a qualcosa che abita dentro di noi molto profondamente, che forse sì ci è meno noto, ma non per questo è meno capace di incidere nella nostra immaginazione, nella nostra forma mentale e nel nostro modo di pensare. La pittura va sì a cercare quello che siamo, ma può spingersi a svelare fondali sconosciuti di cui pochissimo sappiamo. E non sono luoghi senza importanza, cantine chiuse e abbandonate».
Tullio Pericoli, Pensieri alla mano. Da una conversazione con Domenico Rosa (Adelphi, 2014)
Sono dovuto andare fino ad Ascoli Piceno, il 26 maggio 2019, per capire questa riflessione di Pericoli.
Nel bellissimo Palazzo dei Capitani, in pieno centro, sarà esposta fino a maggio 2020 la sua mostra «Forme del paesaggio 1970-2018», 165 opere che ritraggono i paesaggi di Pericoli. La sua Ascoli Piceno, il porto dal quale salpò (per recarsi fisicamente a Milano, dove risiede; ma anche per intraprendere il suo Viaggio, per vivere la sua vita).
Le opere sono esposte in ordine cronologico, al contrario: dalle più alle meno recenti. Iniziano con un duplice autoritratto (di cui parlerò approfonditamente più in là) e finiscono con un’opera emblematica, a mio modo di vedere: Focolaio sismico del 1971. Una vera e propria nascita, dalla terra. Come di un albero – entità che torna spesso in Pericoli. Quanto troviamo nel mezzo, tra le ultime e le prime opere, tra «arrivo» e «partenza», è il percorso, il viaggio, la via verso l’Infinito, meglio ancora: il naufragio di Tullio Pericoli.

↑ Fig. 1: Tullio Pericoli, Focolaio sismico, 1971.
Nei suoi paesaggi ritroviamo la ribellione di un ragazzino di provincia, con un talento demoniaco, che disobbedisce all’autoritario padre nel tentativo di seguire la via segnata dallo sguardo del suo dáimōn interiore: il disegno. È questo suo demone a salvarlo, sempre: dai difficilissimi anni dell’infanzia, quando un cinto erniario, causa dell’indifferenza del padre e dell’ignoranza di qualche medico di paese, lo mortifica per anni, come il cilicio al penitente; all’altrettanto sofferto periodo dell’adolescenza, durante il quale un problema presumibilmente ormonale – anche in quel caso mai attenzionato dal padre – lo mantiene piccolo, inibendone lo sviluppo e lasciandolo preda del bullismo dei suoi coetanei; fino al momento in cui il padre proibisce a Ernesto Ercolani (l’allora migliore pittore della zona) di insegnare l’arte del disegno al giovane Tullio, che aveva guadagnato la fiducia del maestro con i suoi disegni, con grande coraggio, rischiando tutto.
Nei suoi paesaggi troviamo la sua realizzazione milanese. L’esserci «riuscito». Il successo dovuto alla satira sulle riviste e sui giornali, a Fulvia e Pirella. Troviamo la pace, nelle linee che si semplificano, nel tratto che prende sicurezza. Vediamo il ragazzo che diviene uomo. Che si perde nell’azzurro del cielo e nell’astratto dell’orizzonte. Scopriamo la ricerca interiore dell’artista nell’uso dei materiali e delle tecniche, sempre diversi, sempre nuovi. Percorriamo con lui l’esperienza, quasi rinascimentale, di quando Livio Garzanti gli commissiona una intera parete, di una delle sale della sede milanese della casa editrice, la Garzanti degli anni migliori. Possiamo capire la sua crescita, anche interiore, dall’uso rinnovato della tela, dello spazio, dello sguardo. Nei suoi paesaggi c’è il lavoro di scenografo per il teatro, c’è la galleria Marconi, la redazione de «il Giorno», l’incontro con Italo Petra – il direttore – il primo ad avergli chiesto un dipinto di un paesaggio, del suo paesaggio, «un quadro del tuo paese». E pare che su quella richiesta Pericoli si sia interrogato per tutta la vita, e continui ancora oggi a farlo.
«Perciò il suo duplice autoritratto, che lo mostra di spalle davanti allo spettacolo delle sue colline pronte a farsi dipingere, ha un valore squisitamente programmatico: nel volto che indoviniamo dietro l’allusivo profilo con gli occhiali quel paesaggio si riflette e s’incarna».
Salvatore Settis, «La lingua madre di Tullio Pericoli» in Forme del paesaggio 1970-2018 (Quodlibet, 2019)
Io vedo questi paesaggi come una sorta di autobiografia*.
Un autoritratto definitivo – questo è, in fondo, un’autobiografia. Come se, per auto-raffigurarsi, per autoritrarsi, Pericoli rifletta la propria interiorità nel paesaggio, nel suo paesaggio natale che diventa come uno specchio, cambia insieme a lui, cresce, si perde, si realizza e modifica anche il suo modo di vederlo e di vedersi. Tullio Pericoli si racconta attraverso il suo paesaggio, visto – in un gioco di specchi – dal suo geniale sguardo senza orizzonte – o meglio: con infiniti orizzonti che si ripetono e ripetono e ripetono.
* Tuttavia, per avere una visione biografica completa di Tullio Pericoli consiglio la lettura – quasi contemporanea – di Le colline di fronte (Rizzoli, 2011) di Silvia Ballestra e di Incroci (Adelphi, 2019) in cui Tullio Pericoli si racconta attraverso degli aneddoti che riguardano i personaggi che lo hanno accompagnato in questo viaggio incredibile che è la sua vita.
Ritratti, ovvero la re-interpretazione degli sguardi
«La mostra si apre con la duplice versione di un autoritratto davanti alle colline pezzate, immagine veritiera dell’artista che si rappresenta mentre dipinge, le spalle rivolte al lettore, un tubetto di colore poggiato sulla sinistra, il volto di profilo che scorge alla sua destra l’immagine della mano isolata dal corpo, colta nell’atto di afferrare il pennello, le dita intrise dello stesso colore riflesso nell’occhio dell’artista. […] L’autoritratto può essere dunque letto come immagine simbolica che guida i molteplici sensi delle opere, mostrando all’osservatore l’atto del dipingere come filo conduttore dei paesaggi e dei loro procedimenti d’invenzione».
Claudio Cerritelli, «Forme del paesaggio (1970-2018)» in Forme del paesaggio 1970-2018 (Quodlibet, 2019)
Alla fine della mostra «Forme del paesaggio (1970-2018)», ci troviamo davanti i suoi primissimi paesaggi. Vere e proprie Geologie. Pericoli si trasforma in uno speleologo, un archeologo dell’anima – di sé stesso, come dicevamo prima. Cambia tutto, lo stile, i materiali usati, le tecniche. Restiamo sbigottiti davanti a questi quadri materici, dove i fiori sono fatti di chiodi. Ci meravigliamo di questa terra che fuoriesce urlando dalla tela. Gli alberi di chiodi intessono labirinti di radici che si fanno spazio nella terra; terra fatta di corteccia, una corteccia venosa, ancora viva. Il bisogno di toccarli è estremo e irresistibile*.
* Mi vengono in mente le diverse descrizioni di chi ha visitato lo studio di Pericoli. Grandi librerie attorniano un ampio tavolo di lavoro dove libri, fotografie, disegni, suppellettili vari sono accatastati ovunque, accanto ai più svariati strumenti di lavoro, «non solo spatole e normali pennelli, anche spazzole, pettini, punteruoli, pennelli artificialmente induriti, lame» (Claudio Cerritelli), «strumenti impensabili – anche ago e siringa» (Cristina Mesturini).
Accanto alla sala che racchiude questi suoi primi quadri, in un’altra saletta oscura viene proiettato a ripetizione un incontro in cui Pericoli parla profusamente della sua opera (avvenuto alla Normale di Pisa, venerdì 9 marzo 2007. Intitolato Strade Interrotte, e voluto da Salvatore Settis. Potete vederlo e ascoltarlo qui).
Il nipote di – nientemeno che – James Joyce, lo contatta per chiedere l’utilizzo di uno dei ritratti del nonno per una serie di francobolli. Approfittando dell’occasione, il nipote di Joyce vuole togliersi un dubbio e domanda a Pericoli – visto che si trattava del suo testimone di nozze – del colore degli occhi di Samuel Beckett. Chiede perché Pericoli ha fatto gli occhi di Beckett di colore giallo piuttosto che del loro famoso azzurro marino? Pericoli confessa che non aveva mai visto il colore degli occhi di Beckett. Però voleva raffigurarlo con gli occhi di un’aquila.
Questa risposta è bastata al nipote di Joyce, per capire.

↑ Fig. 2: Tullio Pericoli, Samuel Beckett, Otto scrittori (Adelphi, 2003).
Nei ritratti di Pericoli c’è una re-interpretazione significante. Nei dettagli si dipana una storia. Negli occhi di Beckett, colorati di giallo come quelli di un’aquila, si nasconde la sua profondità senza fondo. Il suo sguardo senza limiti.
Per questo motivo, penso, il suo libro I ritratti (Adelphi, 2002) mi fa subito pensare a libri come quelli di Citati, Il male assoluto (Mondadori, 2000) o La malattia dell’infinito (Mondadori, 2008) o il definitivo I demoni e la pasta sfoglia (Quiritta, 2004. Il Saggiatore, 2017) di Michele Mari. Effettivamente, I ritratti è un libro di critica letteraria e culturale, in un certo qual modo. Un libro di ritratti alla maniera del Cioran di Esercizi di ammirazione (Adelphi, 1988) o proprio di Tullio Pericoli, nell’ultimo libro pubblicato, di sole prose: Incroci (Adelphi, 2019).
I ritratti di Pericoli raccontano dei personaggi, delle persone realmente esistite ma trasfigurate dalla loro stessa opera – intesa come il loro operare nel mondo –, come se tutta la loro storia rilucesse nelle rughe, i tormenti negl’occhi e noi potessimo, attraverso la mano e lo sguardo di Pericoli, entrarci dentro e scoprirne il «fondale sconosciuto». Guardando dentro questo abisso, poi, potremmo anche arrivare a riconoscerci – e perciò riconoscerli davvero – sentendo dentro di noi, attraverso i nostri, i loro tormenti, la loro storia nella nostra. E così accade che il nipote di Joyce possa riscoprire e riconoscere Samuel – l’amico, la persona prima ancora che l’artista – attraverso gli occhi gialli di un’aquila.
«Immagino qualche volta di cavalcare un’aquila» dice Pericoli durante l’incontro alla Normale di Pisa (lo riporta anche Settis nella sua prefazione al catalogo della mostra «Forme del paesaggio 1970 – 2018»), «che mi permetta di precipitare e risalire molto rapidamente, e questo mi dà la possibilità di corrompere le prospettive, di falsarle, di vederle simultaneamente da più parti».
Questa è la magia di Pericoli: farci tornare a noi stessi, a casa, dai nostri padri, sulle ali immense di un rapace. Dopo esserci persi nei suoi occhi beckettiani. Dopo il naufragio, il caro vecchio essenziale naufragio.
La sintesi, ovvero l’opera del naufragio
Siamo partiti dalla definizione di Salvatore Settis (la cui prefazione «La lingua madre di Tullio Pericoli» considero un capolavoro di critica) che parlava dei paesaggi e dei ritratti di Tullio Pericoli come due poli in tensione perpetua e irrisolta, incapaci di raggiungersi. Io sono parzialmente in disaccordo (seppure lui usi questa definizione in maniera funzionale al suo discorso e in maniera comunque logica, giustificabile). L’ho scoperto proprio andando alla sua ultima mostra ad Ascoli Piceno.
All’ingresso (come sempre, alla fine torniamo all’inizio, ritorniamo, appunto, alla terra natia) sono esposti tutti i libri di Pericoli (e sono proprio i suoi, le sue copie personali). Tra queste, in bella mostra, era il suo Robinson Crusoe. Che ancora non conoscevo e che mi ha saputo donare la risposta di cui dicevo all’inizio, oltre a riempirmi il cuore.
Si tratta di un’appropriazione, di una rielaborazione di eccezionale levatura. Un furto, direbbe lui.
«Resto affascinata dal suo Robinson Crusoe (Adelphi, 2007) – lo sento “suo” e non di Defoe» scrive Cristina Mesturini. E Silvia Ballestra, la sua biografa, lo pone come un punto di svolta: «Con Robinson Crusoe, un grande lavoro per Olivetti uscito nel 1984, inizia una fase nuova» e lo stesso Pericoli commenta «Alla conclusione del lavoro su Robinson […] mi sentivo pronto per proseguire da solo la mia strada».
Il Robinson Crusoe di Daniel Defoe di Tullio Pericoli è davvero un’opera definitiva. Una sintesi assoluta. Il momento in cui tutto si rimette insieme e torna all’origine, si chiarifica. Tullio Pericoli diviene Tullio Pericoli. Il ragazzo si fa uomo, metaforicamente.
Ad arricchire la forza significante di questo libro è il legame con la letteratura, tipico del maestro marchigiano, il rimaneggiare, il «rubare» (idea cui dedicherà anche una mostra: «Rubare a Klee», in occasione della quale è nata una famosa conversazione con Italo Calvino, racchiusa nell’opuscolo Furti ad arte) ovvero uno dei meccanismi più cari a Pericoli, alla sua maniera di concepire l’opera.
Quel modo creativo di riappropriarsi delle opere del passato, tipico di un certo Carmelo Bene e del suo legame con Shakespeare. Un processo che mi fa pensare molto anche al progetto Beckett on film – per assonanza beckettiana, forse.
E difatti nel suo Robinson, oltre a Daniel Defoe, chiaramente, e all’appena citato Paul Klee, troviamo spiccare ferocemente come un pirata il suo amatissimo Robert Louis Stevenson. È l’immaginario stevensoniano a fare da palinsesto alla struttura di questo testo, a colorarne le ombre, a levigare le forme. È lo spirito di Stevenson a vegliare sul Robinson Crusoe di Tullio Pericoli. E sullo stesso Pericoli, così in questo libro come in tanti altri lavori negli anni a venire.
Robinson è un testo che nasce da un lavoro su commissione, per dei volumi stampati da Olivetti nel 1984, per un pubblico ristretto, a cui venivano regalati per festeggiare la fine dell’anno.
«La scelta di Robinson Crusoe fu quasi immediata. Credo che abbia agito in me il rapporto diretto, il confronto tra l’uomo solo e la natura, un tema che si è affacciato più volte nel mio lavoro. Ma solo più tardi mi accorsi che decisivo era stato un motivo pratico. Il romanzo di Defoe mi avrebbe permesso di uscire da quella doppia situazione che mi stava quasi stremando. In Robinson Crusoe in realtà i personaggi sono due: il naufrago e l’isola, una figura e un paesaggio. Proprio i due temi cui mi stavo dedicando in quegli anni. Avrei potuto unificare i miei stili, facendo diventare personaggio il paesaggio e paesaggio il personaggio. […] Ora sono qui, quasi da soli, a raccontarne la storia e forse finalmente si realizza quella che era la mia vera ambizione di allora».
Tullio Pericoli, Robinson Crusoe di Daniel Defoe (Adelphi, 2007)
E infatti, la versione ultima del Robinson di Pericoli, è un testo a sé stante, in cui troviamo frammenti del Robinson Crusoe di Daniel Defoe, scelti e selezionati in modo profondamente significativo. Essi dialogano con folti gruppi di tavole. Spesso piene di ripetizioni, ossessive. Un tipico tratto dell’arte pericoliana. L’orizzonte che genera altri orizzonti.
«Nel Robinson il concetto di terra, di mappa, è particolarmente forte, è salvezza ed è l’ignoto. Pericoli lo affronta come farebbe il naufrago stesso, con un diario di bordo che riporta meticolosamente ogni esperienza in una catalogazione fantastica, raccogliendo furie meteorologiche, classificazioni geologiche, munizione archiviazioni di strumenti, bestiari esotici. La storia prende forma, così, non attraverso l’azione ma tramite la conoscenza dei vari elementi, e si può comporre e scomporre a proprio piacimento, seguendo il romanzo di Defoe o, meglio, inventandone uno nuovo».
Da Cristina Mesturini «Tullio Pericoli. Terre» in «Il Maradagàl» n° 1, Settembre 2017
È qui che finalmente i due poli si raggiungono e s’incontrano e s’incarnano l’uno nell’altro. È proprio qui che Salvatore Settis si contraddice. Che Tullio Pericoli, usando le parole di Calvino, si contraddice. Persino Robinson si contraddice. Il naufrago che voleva solo viaggiare altrove, resta intrappolato in una piccola isola. Naufraga e si rifugia in sé stesso, nella sua solitudine. Lì, scopre l’infinito. Nell’infinito delle sue fatiche, nel suo volto stanco ornato ora da una lunga barba. Nell’immobilità. Nel suo silenzio, misurandosi con l’isola. Misurandosi con il paesaggio. (Sono significativi, in questo senso, ancora, i titoli dei capitoli che aprono e chiudono l’opera: Il volto e Il ritorno). Robinson non torna a viaggiare, come aveva sempre desiderato. Robinson, come Ulisse, come tutti, come Pericoli, torna in patria: «in Inghilterra […] dopo trentacinque anni di assenza».

↑ Fig. 3: Tullio Pericoli, Robinson Crusoe di Daniel Defoe (Adelphi, 2007)

↑ Fig. 4: Tullio Pericoli, Robinson Crusoe di Daniel Defoe (Adelphi, 2007)
«Volti come paesaggi, paesaggi come volti. Nelle accuratissime esplorazioni, e introspezioni, del volto umano che Pericoli è venuto tracciando, il ritratto sfuma nel paesaggio, specialmente quando si fa drammatico close up come nella serie memorabile costruita intorno al volto di Beckett, scomposto e rappresentato per espressivi, totalizzanti “frammenti”. Rughe sulla fronte come solchi in un campo, occhi come laghi, capelli come boschi: la topografia di quel volto si fa traccia biografica, luogo narrativo. […] Perciò i ritratti di Pericoli sono una chiave di lettura dei suoi paesaggi e viceversa. L’(auto)educazione dello sguardo che egli si propone ha una partitura di fondo, “guardare un volto fino a pensarlo come se fosse un paesaggio, raccontandone gli smottamenti, le frane, i cedimenti, le anse, i solchi, i dossi e le rovine” (cito ancora da Strade interrotte). Si tratta, continuava Pericoli, di una “fertile contaminazione di generi”».
Salvatore Settis, «La lingua madre di Tullio Pericoli» in Forme del paesaggio 1970-2018 (Quodlibet, 2019)
Umberto Eco – che gli era molto amico e che è stato per anni uno dei principali soggetti della sua ricerca ritrattistica – non ha potuto vedere gli «Autoritratti» di Tullio Pericoli. Purtroppo. Credo che sarebbe d’accordo con me nel considerarli un approdo definitivo dell’arte di Pericoli.
Sono due dipinti davvero perfetti. Racchiudono I ritratti, I paesaggi, Robinson, i racconti di Tabucchi (in particolare «Tanti saluti» – pubblicato da Archinto nel 2009, in un volume singolo, assieme a diverse altre tavole di Pericoli).
Dentro questi «Autoritratti» c’è tutto Pericoli. I suoi incontri, le sue rughe, i suoi strumenti insoliti, le marche, Ascoli Piceno, Kafka, Eco, Calvino, Leopardi – sicuramente Leopardi e la sua siepe. Ci sono Stevenson e Manganelli. Montale, Klee, Van Gogh, Giacomelli, Steinberg, Hokusai.
C’è Tullio Pericoli, davvero, in questi «Autoritratti».

↑ Fig. 5: Tullio Pericoli, Autoritratto, 2017.

↑ Fig. 6: Tullio Pericoli, Autoritratto, 2017.
Ecco, forse, se pittura e letteratura hanno una differenza, è che la pittura può riunire ogni cosa in un singolo frammento, in un minuscolo dettaglio.
E anche questo non è vero – anche io mi contraddico – questo può farlo anche la letteratura.
L’unica differenza, forse, sta nella qualità dell’artista che verga il segno. Nell’uomo che c’è dietro.
Tullio Pericoli è uno di quei rarissimi artisti capaci di comprimere tutta l’esistenza, la ricerca, il percorso, il viaggio, il naufragio e il ritorno in terra natia (la morte?) in un gesto – come fosse un gesto di divina onnipotenza –, programmatico e definitivo, che dispieghi, con tutta la sua perfezione magica, il significato di una vita, della vita intera, «il suon di lei».
Questo sono i suoi «Autoritratti», l’inizio e la fine di tutto, l’Infinito.
«Così, sedendo e mirando, aveva guardato il suo infinito. E visto che di infinito si trattava, da allora in avanti, e per gli anni che seguiranno, immagino, Pericoli non ha mai cessato di scoprire nuove prospettive e nuove valli e nuove colline e nuovi boschi, e nuovi cieli, accucciandosi dietro alla sua siepe e naufragando felice nel suo mare di terriccio».
Umberto Eco, L’infinito di Tullio Pericoli, in Tullio Pericoli. Sulla terra, catalogo della mostra (Palazzo Fava, Bologna), Skira, Milano 2015.
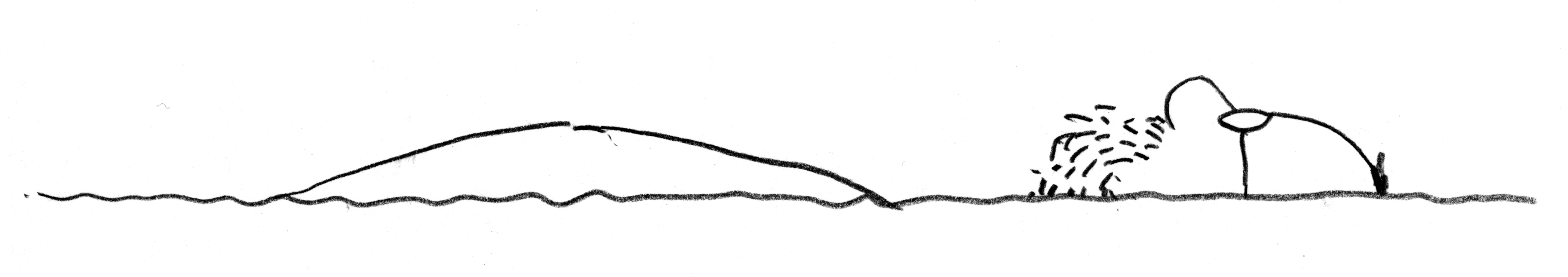
↑ Fig. 7: Tullio Pericoli, Umberto Eco, Incroci (Adelphi, 2019)
________________
↔ In alto:
Si ringraziano Adelphi, Quodlibet e Tullio Pericoli per la gentile concessione della riproduzione delle immagini all’interno del testo.




20 Comments