È il novembre 2004, la Burberry, marchio londinese di gran moda nota per i motivi a tartan su sciarpe borse e cappelli, decide di ritirare un proprio capo dal mercato. Si tratta dei berretti a scacchi beige neri e rossi diventati sinonimo della cultura chav. Il tentativo lungamente inseguito di democratizzare il brand Burberry e trasformarlo da un marchio di alta moda in uno alla portata di tutti si era scontrato sul più bello da un lato con la massiccia contraffazione degli indumenti e dall’altro con l’entusiastica reazione della working class che l’aveva eletta a propria uniforme. In una parola: era diventato troppo popolare.
A un certo punto degli anni Zero, alcuni locali in Inghilterra si riservavano di non farti entrare se indossavi il famigerato tartan Burberry. Danniella Westbrook, una delle star di EastEnders, l’equivalente del nostro Un posto al sole ma ambientato in Essex anziché in Campania[1], viene immortalata vestita da capo a piedi in abiti Burberry, e con lei del tutto abbinata la figlia in una foto che farà epoca. Il Sun da par suo aveva condotto una serie di speciali sui chav indicando ai propri lettori di cosa si parlava con un riquadro a scacchi del brand un tempo di lusso. Insomma, per molta parte degli inglesi dabbene la Burberry si associò per sempre al tizio che li aveva scippati una sera, di ritorno dal secondo spettacolo dell’ultima commedia dolceamara di Hugh Grant.
Ma chi sono i chav?
Be’, di sicuro indossano il cappellino della Burberry che fa bella mostra di sé sulla cover di Chavs: the Demonization of the Working Class. Uscito nel 2011, il libro di Owen Jones partiva dal contestare l’idea dell’estinzione delle classi sociali che a quell’epoca vantava già una lunga storia. Nel 1990, il conservatore di Brixton, John Major prometteva «una società senza classi», un’idea che avrebbe finalmente germogliato con la vittoria dei laburisti nel 1997: «We’re all middle class now» aveva detto John Prescott, il vice di Blair, mentre il suo leader avrebbe decretato «la fine della lotta di classe» un paio di anni più tardi. E se sentite eco dell’abolizione della povertà di recente memoria, quando i balconi erano meno frequentati, il vostro è solo un abbaglio peninsulare.
Chav è un termine che non è stato rivendicato praticamente da nessuno, più che altro si tratta di un insulto volto a designare la teppa antisociale, i proletari che campano di benefits (da noi sarebbero quelli che un Corriere qualsiasi chiamerebbe inevitabilmente «i furbetti del sussidio»), abitano nelle council estates e si ostinano a indulgere in comportamenti giudicati lontani dall’idea di rispettabilità coltivata dalla buona borghesia e dalla working class che fatica onestamente. Città dalla solida tradizione operaia come Burnley, Stockport, Scunthorpe al nord, sobborghi impoveriti come Basildon e Romford al sud, località marittime come Dover, Southend e Blackpool: intere cittadine diventano chav-towns, nascono siti internet che dileggiano chi vi risiede e molti comici faranno le loro fortune con le battute su questi shitholes. Sono gli anni di Little Britain e di Vicky Pollard con la sua tuta Kappa fucsia. Quando salterà fuori che il comico Jimmy Carr aveva evaso tasse per oltre tre milioni di sterline, il collega Frankie Boyle aveva twittato: «A me sta bene che uno evada le tasse a patto che ogni volta che si trova in una città che definisce “un cesso” aggiunga sottovoce: “In parte anche per causa mia, temo”». Qualche tempo dopo ci sarebbe passato anche lui sulla particolare graticola destinata agli evasori.
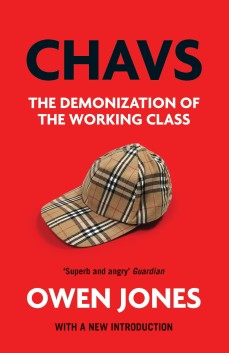
Una dieta a base di Maccy Ds e film su hooligans e criminali di Nick Love come The Football Factory o The Business (il regista almeno avrà la faccia tosta di ammetterlo: «Faccio film per i chav») rigorosamente con Danny «Proper Naughty» Dyer e Tamer Hassan, scarpe da ginnastica bianche e capezze appariscenti. Storia recente e non antica, ancora da digerire quella dei chav, una sottocultura lumpen, ammesso che si possa definirla tale, che sembra pronta a un ritorno in scena col suo corollario di acconciature volgari, nomi di battesimo ridicoli, tute acetate e cibo da asporto ipersaturo. Se all’epoca perfino il principe William aveva partecipato a una festa a tema «chav», e sui siti porno proprio «chav» era una delle parole più ricercate, oggi Netflix si è buttata ai piedi di Matt Lucas per implorare un’altra stagione di Little Britain e Boris Johnson solo qualche mese fa asseriva che le comunità più indigenti sono tali per il basso livello di intelligenza che si può trovare fra i loro ranghi e riforniscono il Regno Unito di «chav, perdenti, scassinatori e tossici» che votano Labour nella malintesa aspettativa di qualche altra «mancetta». I chav insomma non solo sono dei perdigiorno a carico dello stato, ma anche l’ultimo dei gruppi sociali destinatari degli insulti di Boris Johnson (preceduti da donne islamiche, neri, madri single, gay e probabilmente anche chi non riesce a recitare Omero in greco antico o preferisce il calcio al rugby). I chav non se ne sono mai andati.
Rivedere oggi film mediocri come Harry Brown, in cui un senile Sir Michael Caine viene trapiantato dal placido Surrey alle Aylesbury Estate di South London per ergersi a sceriffo contro una banda di chav dopo anni di incattivimento a base di titoli del Daily Telegraph, può avere il sapore del guilty pleasure, come quando si esce gongolanti dopo aver visto l’ennesima amabile schifezza conservatrice di Clint Eastwood al cinema. Ma se già ripeschiamo Eden Lake – un buonissimo film horror di quegli anni su una gita al lago, un soggetto che ha fatto le fortune di tutta una cinematografia di genere – ci si accorge di quanto sotto quella coltre da improvvisati giustizieri della notte fossero in gioco scottanti questioni di classe. I due protagonisti sono una coppia di cittadini beneducati col gippone d’ordinanza per la scampagnata, attrezzati di tenda, gps e tutto l’occorrente per lo snorkeling. Sulla riva del lago però invece della romantica fuga dalla città tanto auspicata incontreranno una comitiva di dodicenni con la faccia di Wayne Rooney, che sparano musica orrenda a tutto volume e sguinzagliano un cane da combattimento che – come dire – rovineranno la poesia dell’incantamento lacustre. Poi, faranno la conoscenza dei genitori di questi ragazzini. Eden Lake diventa insomma Le colline hanno gli occhi britannico, in cui i bifolchi sono stavolta degli ingrugniti northerner.[2]
L’occasione di questo lungo excursus nell’epica dei lumpen britannici è offerta dalla pubblicazione di Chav: solidarietà coatta (traduzione di Alberto Prunetti, Alegre) di D. Hunter. Il libro, inizialmente autoprodotto, raccoglie i brandelli della vita del suo autore, l’esistenza frantumata di un chav di Nottingham, una storia fatta di pestaggi al gabbio, overdose da sostanze, tentativi di suicidio, stupri ripetuti: «una lunga serie di fallimenti» e un costante processo di redenzione per capirsi e fronteggiare una società percepita – non del tutto a torto – come ostile. Oggi, l’autore vive ancora pericolosamente: tra un comfort precario, costruito con una fatica enorme, e un conflitto in cui è immerso fin dalla nascita, sempre sul punto di esplodere.
Esempio di letteratura sociale figlia della tradizione arrabbiata del suo conterraneo Alan Sillitoe[3], quella di Hunter è una biografia basculante tra privato e pubblico, una testimonianza che parte da una presa di coscienza maturata leggendo Gramsci e Angela Davis in carcere, dalla stanchezza di rilevare che i suoi luoghi e le persone con cui ha vissuto per tutta una vita vengono «demonizzati, raccontati in modo paternalista, ridotti a caricature infantili». Il termine chav, spesso brandito anche dalla sinistra borghese, ha di fatto spogliato della sua umanità una vasta porzione di persone, riducendole alla sola (in)solvibilità economica.
«I nostri corpi sono intrisi di connotazioni di classe, e i corpi delle persone senza capitale valgono meno» dice D. Hunter, e fa un certo effetto sentirselo dire da chi per svoltare la giornata alla sua famiglia si è dovuto prostituire dai dieci ai quindici anni istigato da una madre afflitta da turbe e dipendenze, subendo le violenze e le angherie del nonno e dei suoi amici che lo violentavano con una stecca da biliardo, combattendo una mezza dozzina di incontri di bare knuckle boxing[4] contro cugini di secondo o terzo grado. Hunter è cresciuto in una famiglia per metà gypsy e sa bene cosa voglia dire essere una minoranza vessata, ma ciononostante non è mai impossibile trovare qualcuno più scuro di noi: le sue partite di calcio nelle giovanili della squadra della sua città (del Forest? del County?, non è dato saperlo) sono segnate da episodi di razzismo gratuiti, espulsioni e cacce all’uomo, spesso incoraggiate dal padre hooligan, che amorevolmente lo portava in spalla alle marce del National Front. A leggere la sua storia, c’è onestamente di che meravigliarsi che un uomo cresciuto in un ambiente così traboccante di mascolinità tossica e di intolleranza sia divenuto un attivista contro il patriarcato e per i diritti delle minoranze.
A essere meno convincenti sono i passaggi in cui il privato si fa pubblico, la vita diventa pratica e forse teoria. Se il libro ha il tono un po’ santimonioso della denuncia veemente, alla lunga, questa sua spigolosa scrittura in stampatello lo zavorra e si ha l’impressione di leggere un volantino di rivendicazione più che un testo che abbia l’ambizione di stimolare tramite il racconto e magari anche di provocare all’azione attraverso un coinvolgimento empatico.
Penso alle tirate per cui depressione, dipendenze e traumi vengono in blocco accollati a una società quasi scientificamente architettata per compromettere la salute mentale, essendosi votata all’ideale della competizione atomistica. Questo vieto determinismo psicosociale che di questi tempi, specie con la moda di Mark Fisher, passa per innovativo è ben illustrato dalla citazione marxiana scelta come epigrafe da Wu Ming 4 alla sua introduzione: «Non è la coscienza degli uomini che determina la loro vita, ma le condizioni della loro vita che ne determinano la coscienza». Ma se è assurdo descrivere solo come «fallimenti individuali» le vicende psichiche di ognuno, lo è altrettanto radicare tutto solo nel contesto sociale di provenienza o formazione. «Il capitalismo esercita una pressione psicologica più forte sulle persone con meno potere economico»; sarà, ma poi la mia TL su Twitter è invasa da benestanti scrittori depressi.
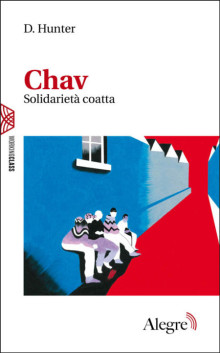
Altrettanto fuori fuoco sono i reiterati attacchi alla sinistra borghese, specchio riflesso del classismo di cui si sente vittima, a buon titolo, l’autore. La solidarietà coatta cui fa riferimento il sottotitolo opera su due versanti: anzitutto è coatta, cioè obbligata, perché i reietti non possono fare a meno di avere gli stessi orizzonti compattati come sono dall’identificazione di un nemico esterno, ma su un altro versante è anche solidarietà fra coatti, fra chi non ha potuto scegliere. Il termine coatto si può serenamente adottare per replicare chav in italiano, anche perché vi si associa un surplus di stigma sociale che non si assegna ai vari truzzi, zarri, tamarri nordici. Si diceva che il chav non ha scelta, e difatti D. Hunter rimprovera piuttosto spesso la provenienza ai militanti delle aree anarchiche e comuniste che frequenta: molti di loro potranno anche aver scelto la povertà o di battersi per i più deboli, ma la scelta è stata libera in partenza e la possibilità fa tutta la differenza in questo caso.
Sono – ribaltati di segno, per carità – gli stessi pseudoargomenti esibiti a destra per etichettare come radical chic gli attivisti, politici, operatori culturali e non doversi preoccupare di dibatterne le idee. Di base gli si rinfacciano due cose: il censo e il tradimento dello stesso. In un mondo rigidamente deterministico come quello marxista che ha in mente l’autore, la cooperazione si fonda quindi su un vincolo quasi paesaggistico più che sull’incontro tra persone, interessi, culture. Un’autorganizzazione dal basso, per una condivisione delle risorse solidale, è necessaria per la montante aggressione portata dal capitalismo. Il che non si traduce necessariamente in una militanza o in una qualche consapevolezza politica. Ma a parere di chi scrive, più che difendersi dal capitale, i chav descritti da D. Hunter ne hanno incamerato e fatto propri i meccanismi, come logico che sia (perché proprio loro dovrebbero essere immuni dalla pervasività di un sistema tanto onnicomprensivo?). Nell’economia informale dei bassifondi cos’è una piazza di spaccio se non la replica di un’azienda?
La difficoltà per l’autore sarà difatti quella di estendere questo mutuo soccorso e ragionare d’insieme con le altre componenti sociali. Una volta diventato attivista politico, il confronto con chi condivide le proprie battaglie da una posizione di privilegio non sarà certo semplice: «Ho trovato difficile far parte dei movimenti sociali in cui i miei compagni avevano l’aspetto, si muovevano e parlavano come i miei giudici, i miei assistenti sociali e le vittime dei miei furti».
Nel 2011 ero a Highgate quando ci sono state le riots e i commercianti di Holloway Road avevano barricato con delle assi di legno i propri negozi; la sera si sentivano solo sirene e di ritorno da un calciotto a Islington mi ricordo di aver pensato di non aver mai visto la città così vuota. La «primavera chav» come l’ha chiamata per farsi due ghignate il cantante dei Travis, riferendosi alla Primavera araba di quell’anno. A leggere D. Hunter si è trattato di una vera insurrezione senza capi contro l’oppressione di stato e capitale, il cui naufragio politico è il risultato dell’insipienza borghese di chi avrebbe dovuto farsi interprete del risentimento del sottoproletariato: gli Owen Jones e i Jeremy Corbyn da cui si attendeva implausibilmente manifestazioni di solidarietà e che invece se ne sono stati belli cheti. Per Hunter non si è trattato di mera criminalità, un’escrescenza di teppismo e ruberie nei quartieri più sofferenti per le politiche neoliberali, bensì di una vera e propria ribellione.
Ma viste a distanza di quasi dieci anni, quelle riots erano largamente spoliticizzate e senza indirizzo: non c’erano rivendicazioni di sorta, e i partecipanti hanno semplicemente snasato la possibilità di fare casino, appiccare incendi, fare incetta proletaria di qualche laptop, vandalizzare il vandalizzabile. Si respirava un’aria interessante e qualcuno avrà voluto trovarsi qualcosa da raccontare agli amici, un domani. Difficile biasimarli, del resto si trattava perlopiù di ragazzi maschi cresciuti all’ombra dei soldi, senza un futuro radioso da immaginare e in piena deindustrializzazione. Come sempre, a fare da miccia era stata la polizia, che durante un’operazione aveva ucciso il sospetto Mark Duggan. Era seguita una dimostrazione pacifica e poi quattro giorni di fuoco, con le rivolte che si estendevano da Tottenham fino a Croydon. All’indomani dei tumulti, molti londinesi bene avevano inforcato la ramazza e inscenato uno tra i primi tristissimi retake.
Riprendendo in mano i vecchi pezzi di Owen Jones, che preconizzavano nuove imminenti guerriglie urbane, si leggono cose così: «Un numero di persone (di tutte le età) si ritrovano inevitabilmente con la montante sensazione che il futuro sia nero. In queste circostanze, rabbia e frustrazione aumenteranno e se non verranno canalizzate e indirizzate politicamente, potrebbero manifestarsi nel peggiore dei modi». Al contrario delle previsioni di Jones però, quelle sommosse sono morte lì e non hanno avuto seguito. Anche Hunter si cimenta in foschi (o dal suo canto allegri) presagi per la prossima esplosione della rabbia lumpen. Ma forse vale la pena riprendere proprio Marx quando indicava nel sottoproletariato una classe sociale senza coscienza politica e disorganizzata sindacalmente che avrebbe finito per essere sfruttata dalla reazione borghese. Insomma, forse non è dai chav che dovremmo attenderci la rivoluzione.
Negli anni, puntare sulla solita guerra fra poveri, dividere la comunità e aizzare middle class e proletariato «aspirazionale» contro i chav è servito a foraggiare una narrazione votata a delegittimare e smantellare lo stato sociale. Oggi, uno di quei bruttissimi cappellini della Burberry costa circa 300 sterline, ma chissà che non possa tornare di moda per l’orrore di matusa, benpensanti e borghesi, e magari spuntare vittorioso da una barricata agitato in aria da masse di Chantelle e Dwayne col doppio cognome.
[1] Mi contesto il parallelo da solo, forse il vero Un posto al sole inglese è Coronation Street, anche perché il vero mezzogiorno d’Inghilterra è il nord. Eastenders vale come Centovetrine? Difficile da dirsi, ma visto che siamo in lockdown il consiglio dell’anglofilo è recuperarsi The Royle Family del buon Ricky Tomlinson, Two Pints of Lager and a Packet of Crisps, la più recente White Van Man, ma soprattutto Only Fools & Horses e Citizen Smith.
2] A Owen Jones, comprensibilmente, il film non è piaciuto. «Dopo piazza di Spagna, i torpigna ci hanno invaso pure il lago!»
3] Nell’articolo è citato anche The Football Factory, un film tratto dall’omonimo libro di John King (in italiano: Fedeli alla tribù, traduzione di Massimo Bocchiola,TEA). Qualche anno fa, proprio John King assieme a Martin Knight (autore del meno buono ma godibile Barry Desmond Is a Wanker) hanno fondato una casa editrice, la London Books che tra i principali meriti ha quello di tenere in catalogo e in vita le opere di Alan Sillitoe. Entrambi, sia King che Knight, hanno il vistoso difetto di essere del Chelsea, con tutto ciò che una simile infelice scelta comporta.
[4] Per chiunque non sapesse di cosa si tratti il consiglio è procurarsi e leggere The Guv’nor di Lenny MacLean. Forse vi ricorderete di lui nelle vesti di Barry the Baptist in Lock, Stock & Two Smoking Barrels.




“KUBET, the number 1 trending direct website in 2023, the direct website that has been opened and has been properly licensed. We provide many online games including sports, casinos, slots, fish shooting and others. We are certified and safe in security. All members can be confident that they can make transactions accurately and transparently.
Apply now, free bonus 100% LINE: @KU555 apply at https://www.ku66.vip
https://www.k288.net/
Game online
best of the years
https://www.k288.net/
Game online
best of the years
โปรโมชั่น ฝาก100 รับโบนัสฟรีอีก100%
เล่นได้ทุกเกม ถอนได้ไม่อั้น
LINE: @ku123
KUBET เว็บแทงบอลออนไลน์อันดับ1ของเอเชีย แทงง่าย ค่าน้ำดี
https://www.kusports8.co/KUsports/
https://www.k288.net/
Game online
best of the years
โปรโมชั่น ฝาก100 รับโบนัสฟรีอีก100%
เล่นได้ทุกเกม ถอนได้ไม่อั้น
LINE: @ku123